| |
Fonte : I miei ricordi - Massimo Taparelli D'Azeglio
(Capo Decimoottavo)
(Letteratura Italiana Einaudi - Edizione di riferimento : Barbera,
Firenze 1891)
|
 |
|
... sulle accademie e le Società Promotrici
|
|
|

Non mi pare che a questo punto il dire quattro parole
sull’arte mia, venga fuor di proposito. Se lei non è
pittore, e non se n’interessa, c’è il solito rimedio: salti.
Nel secolo XVIII la società era giunta in ogni genere agli
ultimi confini dell’artificiale, dell’affettato, dello
sconforto, dello stravagante, dell’illogico ecc. ecc. Si
potrebbe estendere quest’osservazione a sfere più alte ed
importanti, ma son cose ormai dette abbastanza. Mi contento
d’osservare che le aberrazioni del gusto, nelle cose appunto
di gusto, erano spinte fino all’incredibile. In fatto di
mode, quei castelli incipriati che vediamo ne’ ritratti di
donne, con un cappellino di paglia o una corona di rose
sulla cima: e in fatto d’arti, li acquarelli, verbigrazia,
di paese, d’una sola tinta, e quale? lacca rossa, o cinabro
puro!!! I giovani che non le hanno vedute, non mi
crederanno, ma le ho ben vedute io, e non avevo le
traveggole. Anche in arte vi fu allora un gran movimento
verso il culto del vero. Nella pittura storica l’influenza
delle idee greco-romane, che servivano o si facevano servire
alla politica del momento, popolò le tele d’Achilli, di
Aiaci, di Milziadi, di Orazi e Curiazi, di Gracchi ecc. ecc.
Si cercò col vero dinanzi la forma antica nella sua monotona
affettazione; si volle vedere il nudo da per tutto, fino
sotto le vesti; si dipinsero figure che sembrava le avessero
indosso bagnate. La mania arrivò al punto che per uno
scultore classico l’umbilico fu visibile sotto la corazza
del medio evo, ed un disegnatore dovendo rappresentare
Napoleone in piedi, segnava la rotula sotto lo stivale a
tromba!
La pittura di paese viveva invece in un ambiente scarico di
passioni politiche, e tenne una via più ragionevole. Dai
chiaroscuri di lacca o cinabro, dai manieristi de’ quali
rimangono i saggi nei sovrapporti de’ quartieri signorili di
quel tempo, si passò all’imitazione esatta, minuta del vero,
senza mettervi nè per l’argomento, nè per la forma o per
l’effetto, ombra d’immaginativa. Hackert fu tra’ primi ad
applicare quella teoria così semplice in apparenza, ed in
sostanza così spesso negata: esser l’arte il ritratto del
vero, Nè potendosi far ritratto veruno senza conoscere
l’originale, doversi studiare questo vero e metterselo in
capo quanto è possibile. Egli morì a Firenze nel 1807. La
contessa d’Albany aveva un suo paese assai grande,
rappresentante un bosco d’alto fusto con un lontano, ed
alcuni cervi sul davanti. Io lo ricordo in nube, fra le mie
prime impressioni, e rammento che lo guardavo ed ammiravo
lungamente. Il suo talento, l’incontro del suo nuovo stile,
la sua fama, le ricchezze acquistate, allettarono, come
sempre accade, numerosi imitatori.
Per una ventina d’anni e più, fiorì in Roma la sua
scuola. Woogd, Therlink olandesi, Verstappen fiammingo,
Denis e Chauvin francesi, Bassi bolognese, furono i
dominatori di una delle più felici epoche artistiche delle
quali abbia memoria. Essi si trovarono artisti provetti e
nel vigore dell’età, nel 1814, quando l’Europa non ne voleva
più dell’odore della polvere, nè della vista del sangue, ed
anelava di ricrearsi lo spirito colle benedizioni della
pace. Gl’Inglesi, più degli altri, tenuti in quarantena da
tanto tempo nella loro isola, si versarono come una lava sul
continente; e se in Italia non ebbero l’intelligenza
dell’arte, ne professarono però l’idolatria: talchè i
pittori sunnominati non bastavano a contentare tutte le
richieste. Ogni artista aveva un soggetto nel quale era
tenuto più felice. Mi ricordo che la cascata del Velino era
il soggetto di Bassi. Credo che in parecchi anni ne facesse
più di sessanta; che in fine, per esser sinceri, sembravano
un po’ fatte colla stampiglia. Io seguivo scrupolosamente i
precetti di quella scuola, e credo che siano i migliori.
Dipingevo dal vero in tele di bastante grandezza, cercando
di terminare lo studio, a quadro, sul posto, senza
aggiungere una pennellata a casa. Studiavo in dimensioni
minori, pezzi staccati, sempre ingegnandomi di finire più
che potevo. Questo era il lavoro della mattina. Dopo pranzo
disegnavo pure dal vero, terminando con molta cura e
studiando ogni rilievo. Con questo metodo, il soggiorno di
Castel Sant’Elia d?un paio di mesi, mi fece fare i primi
veri progressi, e mi cavò fuori dalle difficoltà materiali
dell’esordiente.
Il finire sul vero, come si finirebbe un quadro nello
studio, serve a cercare lo sfondo coi mezzi semplici della
natura, e non coi contrapposti forzati d’un’arte manierata:
ricordandoci però sempre che i mezzi nostri sono
limitatissimi, mentre sono infiniti quelli della natura.
Essa ha la luce sulla sua tavolozza, e noi ci abbiamo la
biacca. Siamo dunque costretti d’aiutarci cogli artifizi, e
perciò si dice arte. È facile il procurare lo sfondo ad un
lontano vaporoso e cilestrino, con un grosso albero nero che
gli si metta davanti, all’uso de’ manieristi; ma è men
facile ottenere simile sfondo, coi mezzi infiniti usati
dalla natura, che tante volte è chiara sul davanti e scura
in lontano. Non solo è men facile ma è impossibile
avvicinarsele, se non s’altera in una data misura la
prospettiva aerea, se non si trascura, l’indietro e non si
finisce l’avanti un po’ più che nel vero. Anche
quest’artificio deve però stare in certi limiti. E come si
fissano? col talento e col gusto. La prima, la vera molla
dell’arte sta in loro: l’ispirazione è il fervido raggio che
solo ne può fecondare i germi. Nella pittura di paese si
possono suggerire precetti, osservazioni, ecc., ma se non
s’opera per ispirazione, tutto è inutile. Per questo i
grandi paesisti sono stati più rari che i grandi in altri
rami dell?arte. Il metodo che accenno, io l’ho seguito per
moltissimi anni, passando in villa tutta intera la bella
stagione. Ora invece si studia meno ed in altro modo dal
vero. Quale de’ due metodi è il buono? Il migliore forse
sarebbe quello che partecipasse d’ambedue.
Gli anni di validità al lavoro sono misurati all’uomo. È
bene dividerne l’impiego. Prima di tutto il paesista deve
imparare a riprodurre il vero, poi a far quadri Io forse
diedi troppo al primo stadio, e troppo poco al secondo;
mentre per far bene, si deve lasciare spazio conveniente ad
ognuno di loro. Ora se ne lascia troppo poco al primo. Ma
l’arte è tutt’altra da quello che fu trent’anni sono; essa
procede da altri impulsi, vive in altri ambienti, e stretta
da altre necessità. Quella maledetta frase che ha ingannata,
e fatta morire o vivere di stento tanta gente ? proteggere
le belle arti! ? frase che si credette ridurre a fatto
coll’istituire le Accademie di Belle Arti, porta ora i suoi
frutti.
|
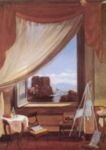
A forza di fabbricare artisti, l’arte è dovuta diventare
un’industria; e siccome in essa e assai più l’offerta che la
domanda, s’è dovuto pensare a provvedere a quella massa di
lavoranti necessariamente a spasso. A questo effetto, le
buone persone di molte città hanno istituite le società
promotrici, veri luoghi pii: ed i governi concorrono alle
spese, ed impiegano i denari dei contribuenti ad acquisti,
che scampano quella massa d’artisti, i quali secondo le
regole economiche, sarebbero giustamente disoccupati, dal
morire letteralmente di fame. Ed anch’io quand’ero ministro
feci come gli altri: che Dio ed i contribuenti perdonino il
mio peccato!
Ma proprio, par impossibile a vedere certe volte come gli
uomini sono zucconi. Ed il più bello è che oggi non si
discorre che di leggi economiche, di libero commercio, di
valor reale, di domanda e d’offerte! Facciamo un’ipotesi.
Suppongo una città di 50 mila anime: dunque circa 25 mila
maschi, 15 mila adulti, e perciò circa quindicimila teste
che chiedono un cappello. Ci sono cappellai che li
provvedono; se il lavoro cresce, chiamano altri garzoni; se
cala, li rimandano, e questi cercano nuovo cielo. Così tutti
campano, e nessuno s’ha da incaricare di loro. Ma viene al
mondo un grand’uomo, che diventa Ministro, e si persuade che
bisogna proteggere la Cappelleria; istituisce un’Accademia,
e vi chiama i più distinti cappellai del paese, li paga
bene, e quelli insegnano meglio, dimodochè ogni anno si
mettono in attività tanti cappellai nuovi, de’ quali non c’è
bisogno, perché non ci sono più capi da coprire; questi non
avendo pane, stridono, si lagnano, tribolano il pubblico, ed
allora le anime buone fondano una società onde comprare i
cappelli d’avanzo, tanto da dar da vivere ai cappellai
altresì d’avanzo: ed il ministro presenta alle Camere una
domanda di fondi onde concorrere alla spesa. Ma non era
meglio risparmiare quell’altra spesa, e non mantenere
fabbrica di cappellai pei quali non c’è lavoro?
Questa forma di protezione della Società promotrice, ha poi
altri inconvenienti. Primo, quello di stancare il prossimo a
furia di strofinargli sotto il naso queste benedette belle
arti. Volete che una cosa alletti? fate che se ne desti
desiderio; e oramai non c’è più angolo da rifugiarsi, dove
non si trovi qualche ramificazione di quel proteggere
benedetto. Però non è peccato italiano il pensiero delle
Esposizioni perenni. Di chiunque sia è stato un malaccorto
peccato. Secondo inconveniente. Chi espone, salve pochissime
eccezioni, ha bisogno di vendere, anzi necessità, anzi
l?hanno più di lui i suoi creditori. Se quel tal quadretto
si vende, il sarto, il calzolaio, il coloraio hanno o il
saldo, o un acconto, col quale si fonda il credito per un
altr’anno. Per conseguenza si mettono in moto compari e
comari, protettori, amici, si va a far riverenze in ogni
senso e d’ogni misura a ministri, impiegati, uscieri, nè si
tralasciano tutti quegl’invisibili fili di sesso femminino
che danno occulto moto ai meccanismi della società. Per
conseguenza i caratteri si abbassano, si falsano, e quella
tal protezione all’arti belle si muta o in un’opera di
misericordia, o in un ignobile e corruttore impulso.
Almeno ci guadagnasse il gusto del pubblico e degli artisti!
Ma invece ecco un altro inconveniente. Il bisogno di vendere
conduce logicamente al bisogno di farsi osservare e
distinguere dagli altri; quindi al bisogno d’esser di moda,
e seguire non la coscienza, preziosa nell’arte come in ogni
altra cosa, ma il capriccio del giorno. Quindi star sempre
all’erta, per scoprire di dove spira il vento, e riprodurre
non quel vero e quel bello che ogni artista sente in sè, ma
quel tal genere, quel tale stile che ha incontrato, sia qui
sia altrove, il suffragio del pubblico e soprattutto de’
compratori. Perciò non si cerca più di fare arte propria e
sentita; ma di copiare quello o quell’altro pittore che è in
voga a Parigi o a Londra; e l’arte diventa un contraffare
più o meno esatto e felice. Di qui poi ne segue una strana
stonatura delle idee oggidì più generali. S?ama
l’indipendenza, si ama la nazionalità, s’ama l’Italia, anzi
in generale i paesisti sono accordati al corista di Roma o
morte; e poi se prendono il pennello in mano la sola cosa
che non fanno è l’Italia!
La magnifica natura italiana, la splendida luce, le ricche
tinte del cielo, nessuno la crede degna d’essere ritratta!
Si va alle esposizioni, e che cosa si vede? Un paese del
nord della Francia, imitazione del tale. Una marina, presa a
Etretat o a Honfleur, imitazione del tal altro. Una landa in
Fiandra, un bosco a Fontainebleau, imitati da Dio sa chi; e
tuttociò coi cieli sbiaditi, la luce morta di que’ climi,
colle tinte impolverate come se un velo color di terra
stesse loro davanti; e se talvolta trattano soggetti del
nostro paese, sembra che temano dì mettervi luce e verità;
che temano l’azzurro del cielo, il verde delle piante, e
fanno un’Italia ammalata al soffio del vento del nord!
Mentre sono nati nella vera patria d’ogni bellezza naturale,
sotto il limpido e potente raggio d’un sole, che colora e
pianure e mari e monti ed alberi ed edifizi di quelle tanto
mirabili intonazioni, preferiscono un’arte serva d’altrui;
un’arte che aspetta da Parigi o da Londra i suoi modelli e
le sue ispirazioni, colla pacotille dell’altre nouveautès
dell’anno; preferiscono una natura senza anima, senza
carattere, fiacca e smorzata, da rassomigliarsi ad un
istrumento che abbia la sordina; e per essa rinnegano
l’Italia e quel suo cielo, quelle sue bellezze, che pur
troppo chiamarono sul nostro suolo, un tempo, già tanti
nemici, ma che graziadio oggi vi chiamano soltanto amici che
non mai si saziano di magnificarle!
|

I boschi, i querceti, i castagneti che vestono il lungo
dorso dell’Appennino, non reggono forse al paragone della
foresta di Fontainebleau? Le marine d’Albenga, di Sestri, di
Port’Ercole, di Sorrento, d’Amalfi splendono forse meno di
quelle d’Etretat e di Trouville? l?onda gialla dell’Oceano,
è forse più poetica che l’azzurro flutto del Tirreno e del
Jonio? L’indipendenza non vale d’averla sulla lingua se non
s’ha nel cuore, ed in tutto: anche nell’arte. Siamo nazione,
siamo Italiani, siamo noi una volta in ogni cosa, in ogni
genere, sotto ogni forma, ovvero, se non si vuol far più,
gridiamo meno. Que’ paesisti invece che ho citati del 1814,
tutti stranieri, salvo Bassi, trovavano pur degna l’Italia
d’essere ritratta, e tutta l’Europa fu della loro opinione.
Ancora ho davanti agli occhi le spiagge di Napoli e di Baja
di Denis; le Forche caudine di Chauvin: gli orizzonti della
campagna di Roma di Woogd; le macchie della Nera di
Verstappen, e la cascata delle Marmore di Bassi. A Napoli
Vianelli, Gigante, Smargiasso, Carelli e molti altri non
ebbero bisogno di lasciare i loro climi felici per farsi
nome e ricchezze, e Dio sa che tempi eran quelli nel senso
politico! Ed ora quando tutto dovrebbe spirare indipendenza,
azione spontanea, libera ed originale iniziativa, la mia
povera arte del paesista ha da esser servile, piaggiatrice,
copia di copia d’una natura che non è la sua e che n’è
lontana le mille miglia?
Dopo aver detto quel che penso sulle accademie e le Società
promotrici, dell’originalità, dell?indipendenza artistica,
sono il primo a riconoscere che sarebbe errore considerarle
come fatti isolati. Esse sono frutto delle condizioni del
mondo moderno, e tutti i ragionamenti possibili non servono
a mutarlo. Si seguiterà per un gran pezzo a proteggere le
belle arti, come l’orso della favola proteggeva l’uomo
contro le mosche; si seguiterà a copiare gli artisti di
moda, anzi a contraffarli, come s’usa per medaglie, armature
e curiosità antiche; si seguiterà ad ubbidire il pubblico
ne’ suoi capricci di cattivo gusto, invece di correggerlo e
condurlo al bello, al vero ed al buono; si seguiterà a
generare artisti superflui, ed a tenerli vivi, colle
Promotrici; io seguiterò a pagare la mia quota per
mantenerle in fiore, ed avrò in ultima analisi il destino di
tutti i predicatori. In questo caso l’ostacolo non sta già
nel non capire: tutti invece, parlo di chi ha sale in zucca,
e se n’intende, pensano allo stesso modo, ma sta nella forza
d?inerzia.
L’abitudine è mezzo padrona del mondo: così faceva mio padre
? anche in quest?èra di rivoluzioni ? è sempre una delle
grandi forze che guidano il mondo.
|
|
Massimo Taparelli D'Azeglio
|
|
|
|
|
|