| |
(Fonte : Dedalo - Rassegna d'arte diretta da Ugo Ojetti,
Milano-Roma, - 1922-23)
|
 |
|
IL BOZZETTO DEL NAPOLEONE DI CANOVA
|
|
|
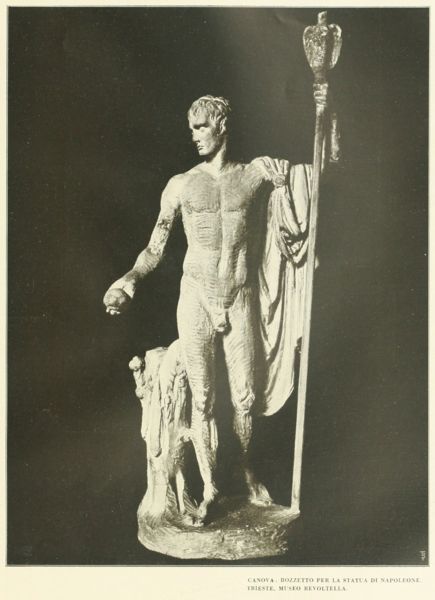
In una sala del Civico Museo Revoltella, già fastosa
abitazione del ricco mercante che ne fu il fondatore e il
donatore alla città di Trieste, e che raccoglie le opere
d'arte moderna dall'ottocento ad oggi, si può vedere,
collocato in un angolo e sorretto da una colonna, un
bozzetto in gesso di modeste proporzioni
(1). Ignorato dai
più, anche dagli studiosi, il piccolo capolavoro è passato
quasi sempre inosservato, nel suo angolo tranquillo, fra il
luccichìo degli specchi, i riflessi dei mobili dorati e
delle ricche suppellettili, ostentanti il lusso artificioso
caratteristico della metà del secolo scorso.Eppure quale
soffio purissimo di vita e quanto magistero d'arte sono
racchiusi in quel piccolo gesso! Le riproduzioni che per
primi abbiamo la soddisfazione di offrire al godimento dei
lettori, ci esimono dal dilungarci in descrizioni. Si tratta
del gesso originale ricavato dal bozzetto in creta in cui
Antonio Canova fermò la sua prima idea per la grande statua
dedicata a Napoleone Bonaparte, Primo Console. Esso dovrebbe
risalire perciò allo spazio di tempo che va dal 1803
all'805, al più tardi. Com'è risaputo, il Canova eseguì il
primo ritratto del Bonaparte quando, dopo molto
tergiversare, aderì all'invito di recarsi a Parigi, ove si
fermò fra il settembre e l'ottobre del 1802. Vi ritrasse il
Primo Console in un busto grande al vero. Cinque anni più
tardi, egli aveva già compiuto a Roma il modello della
famosa statua colossale rappresentante l'Imperatore in
quell'eroica nudità che così varie discussioni doveva
sollevare e che, eseguita in marmo, era destinata alla
capitale francese. |
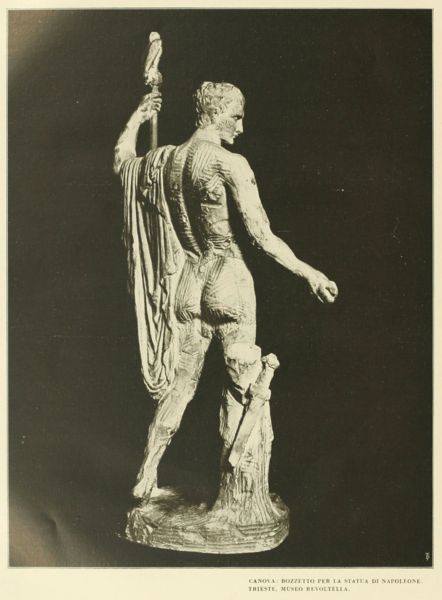 Nel frattempo, il Vicerè Eugenio Bonaparte, sinceramente e
profondamente ammirato dell'opera insigne, ne ordinava una
riproduzione in bronzo, in minori dimensioni, da collocarsi
in una piazza di Milano. Non ci attarderemo a narrare le
vicissitudini per le quali il colosso marmoreo, arrivato a
Parigi nel 1811, passò poi a Londra in possesso del Duca di
Wellington, ed il bronzo, fuso a Roma un anno prima, non fu
collocato a Milano alla vista del pubblico che nel 1859.
Diremo soltanto che della statua eroica di Napoleone
esistono ancora due gessi: uno, l'originale, a Possagno e un
secondo a Roma.
Nel frattempo, il Vicerè Eugenio Bonaparte, sinceramente e
profondamente ammirato dell'opera insigne, ne ordinava una
riproduzione in bronzo, in minori dimensioni, da collocarsi
in una piazza di Milano. Non ci attarderemo a narrare le
vicissitudini per le quali il colosso marmoreo, arrivato a
Parigi nel 1811, passò poi a Londra in possesso del Duca di
Wellington, ed il bronzo, fuso a Roma un anno prima, non fu
collocato a Milano alla vista del pubblico che nel 1859.
Diremo soltanto che della statua eroica di Napoleone
esistono ancora due gessi: uno, l'originale, a Possagno e un
secondo a Roma.
Questo bozzetto di Trieste ha dunque un valore ed un
interesse particolari. Alto appena 74 centimetri (fino
all'aquila 86.5 cm.), ma curato in ogni sua parte, esso
rivela quale precisa e chiara visione l'artista abbia avuto
sin dal principio nel concepire la sua opera. Fra il
bozzetto e la statua bronzea di Brera (che è l'esatta
riduzione del colosso in marmo di Londra) ed alla quale
sempre ci riferiremo, non esistono differenze sostanziali.
Le proporzioni e la posa della figura, i movimenti della
testa e degli arti sono gli stessi; così il tronco d'albero
che serve di appoggio, le pieghe della clamide, ecc.
Solamente nel bozzetto manca la piccola vittoria alata e vi
si vede in più l'insegna dell'aquila.
|
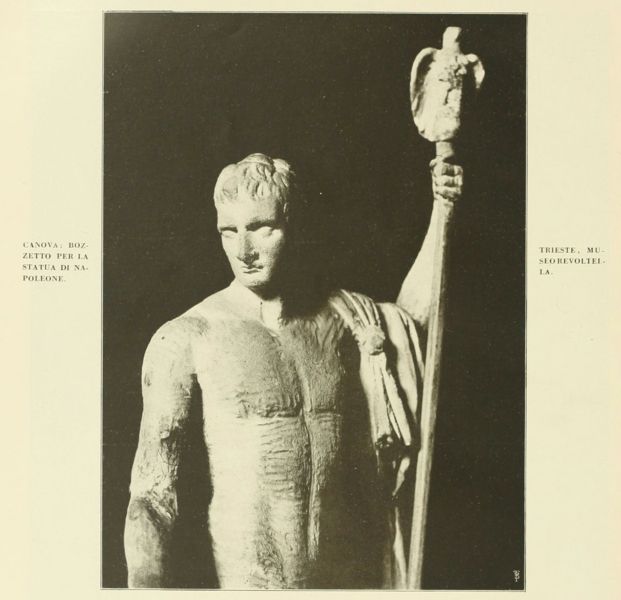
Passando a più minuto esame, noteremo che il bozzetto ha
qualità stilistiche differenti in confronto dell'opera
compiuta. Plasmata con una meravigliosa, invidiabile
bravura, di primo getto, senza pentimenti, quasi con foga e
quasi esclusivamente a colpi di stecca dentata, la figura di
questo gesso originale, che nella sua scrupolosa fedeltà
tiene il posto dell'argilla malleabile che conobbe l'ardore
creativo dell'artefice sommo, ha un senso di vita maggiore
che nell'opera di bronzo. Lo si scorge nei profondi segni
delle attaccature dei muscoli, nella modellazione poderosa
della schiena e dei fianchi e nel modo con cui è reso il
movimento elastico e nervoso degli arti inferiori. Anche la
testa, superbamente condotta, ricavata direttamente dal
primo ritratto eseguito a Parigi, espressiva ed
affascinante, è, rispetto al corpo, in più giusto rapporto.
Nel bronzo, invece, l'artista si è preoccupato di
perfezionare il modellato e le proporzioni, seguendo i
canoni di bellezza eroica e classica che si era prefissi e
che, più che altrove, il monumento richiedeva. La testa,
rimpiccolita ed idealizzata, ha perduto gran parte del suo
fascino; il torace è maggiormente sviluppato, tanto da dare
al tronco una forma sensibilmente piramidale, gli arti sono
più torniti, carnosi, un po' inerti.
Questo bozzetto, tardivamente ma poi in tempo illustrato,
così pittoresco nell'insieme, reso con così vivace senso
della forma in movimento, uscito con tanto calore
d'improvvisazione dalle mani del grande plastico, basterebbe
da solo a rivelare, finalmente, se alcuno non lo avesse già
intuito, quale indiscutibilmente chiaro elemento di
congiunzione rappresenti l'arte canoviana - pur nel suo
classicismo sempre tradizionalmente italiana - fra la
scultura barocca e quella dei nostri giorni.
|
|
ALBERTO RICCOBONI |
|
|
|
|
|