| |
(Fonte : Dedalo - Rassegna d'arte diretta da Ugo Ojetti, 1926-27)
|
Pag. 1/2 |
|
LA RACCOLTA FIANO
|
|
|
 Visitai, anni fa, la «quadreria» dell'avvocato Emanuele
Fiano a Roma, nell'intento, sopratutto, di conoscere la
produzione che Armando Spadini, dal 1911, v'era andato
«depositando». A non voler dire, addirittura, «nascondendo»,
è questa la parola esatta; ché se Spadini aveva bisogno di
vendere, era però ansiosissimo che le sue pitture fossero il
meno possibile viste. Di qui la sua repugnanza ad affidarle
a negozianti; il suo rifuggire dalle esposizioni, nel dubbio
d'esser ancor giunto ad offrire una degna testimonianza di
sè. L'avvocato Ilo Nunes e il dott. Angelo Signorelli,
l'avvocato Fiano e il senatore Olindo Malagodi, offrivano
alle sue opere un asilo famigliare, aperto alla curiosità di
pochi. E si può credere che, allo Spadini, il numero di
questi pochi non sembrò mai abbastanza ristretto.
Visitai, anni fa, la «quadreria» dell'avvocato Emanuele
Fiano a Roma, nell'intento, sopratutto, di conoscere la
produzione che Armando Spadini, dal 1911, v'era andato
«depositando». A non voler dire, addirittura, «nascondendo»,
è questa la parola esatta; ché se Spadini aveva bisogno di
vendere, era però ansiosissimo che le sue pitture fossero il
meno possibile viste. Di qui la sua repugnanza ad affidarle
a negozianti; il suo rifuggire dalle esposizioni, nel dubbio
d'esser ancor giunto ad offrire una degna testimonianza di
sè. L'avvocato Ilo Nunes e il dott. Angelo Signorelli,
l'avvocato Fiano e il senatore Olindo Malagodi, offrivano
alle sue opere un asilo famigliare, aperto alla curiosità di
pochi. E si può credere che, allo Spadini, il numero di
questi pochi non sembrò mai abbastanza ristretto.
Fu una fortuna che cotesti amatori provvedessero a diminuire
la dispersione che l'opera dell'artista avrebbe subita, se,
impaziente come egli era, ed incapace agli affari, egli
avesse dovuto totalmente affidarsi al gusto di acquirenti
d'avventura e al commercio. Un largo disperdimento non fu,
tuttavia, ovviato; ed ogni giorno me ne persuado, cercando
di ricostruire un completo catalogo delle pitture e disegni
dello Spadini. Pezzi assai importanti andarono ad annidarsi
in sedi impervie. Comunque, la parte più numerosa ed eletta
è suddivisa fra le quattro raccolte suddette; e, per numero
e varietà, la raccolta Fiano certamente primeggia.
|
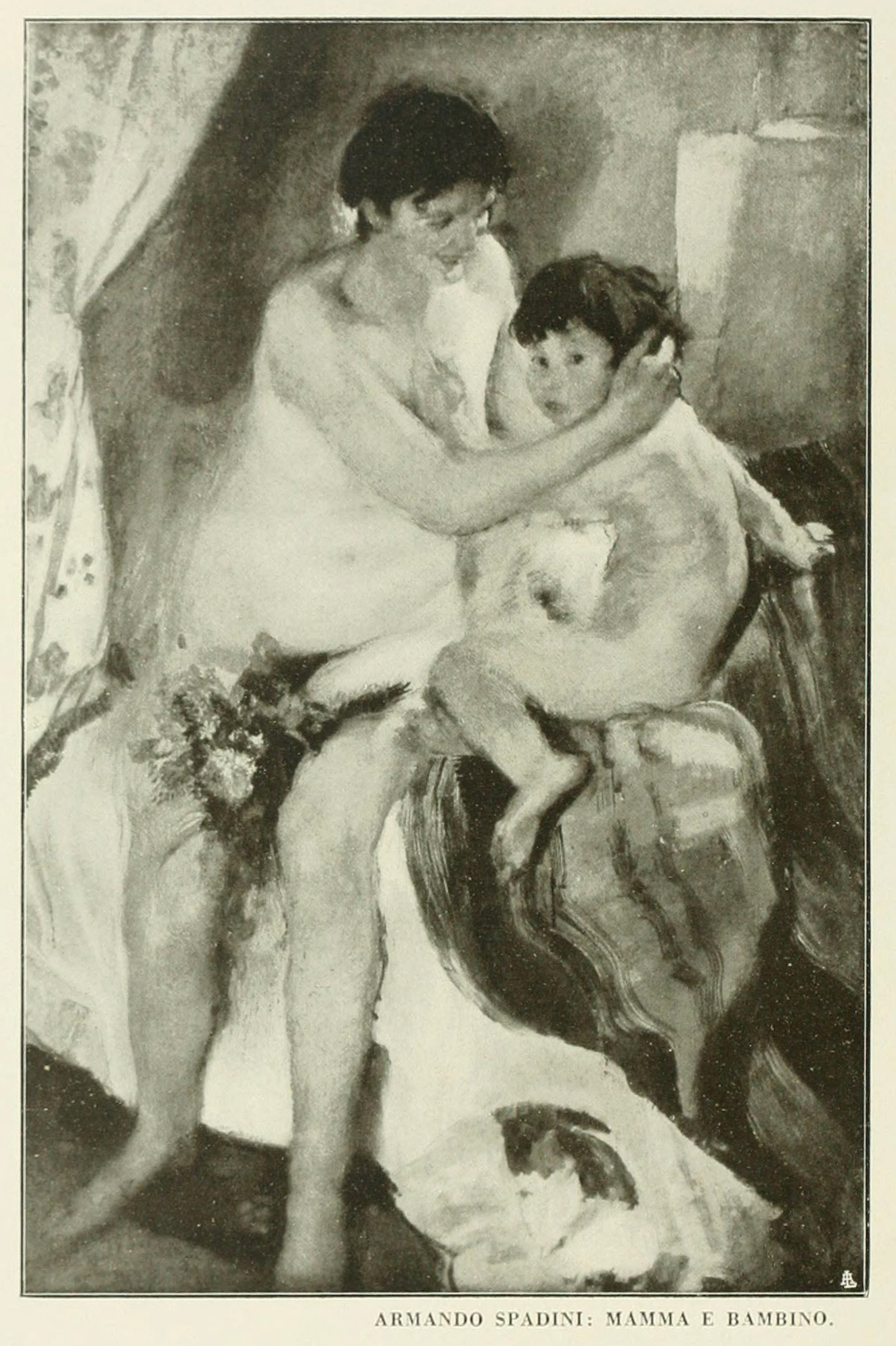
 Questo materiale fu già, parzialmente, illustrato, nelle
pubblicazioni che allo Spadini dedicarono l'Ojetti, l'Oppo,
il Colasanti, il Soffici e il Mariani
(1); e forma il nucleo della «quadreria»
che, frattanto, vorremmo considerare nelle altre opere
ch'essa aduna: di italiani e stranieri; in special modo,
pittori della nostra seconda metà dell'Ottocento. E quando
avremo ricordato Spadini nel Mosè salvato dalle acque
(m. 2,67 X2,13), che rappresenta il suo massimo sforzo di
composizione, cui egli era venuto, dal 1911, preparandosi
con il primo Mosè (ora nella raccolta Bastianelli):
con un altro, pure di gran superficie, distrutto; e, al
Mosè (pagg. 705-707), avremo aggiunto: Bimbi al sole
(pag. 709), una delle sue tele di luminosità più robusta ed
equilibrata; e, con qualche altro saggio delle cose
«minori», la magica Bambina tra le corolle (pag.
706); non sarà che un minimo omaggio ad un'arte ch'è vanto
di scrittori di Dedalo avere, da anni lontani,
esaltata; e che questa collezione documenta in ogni periodo
del suo sviluppo: dallo spagnuolesco ritratto della
Fidanzata a quello della Madre (1907); alle
Tre età e all'Autoritratto con la moglie (1910);
alle «conversazioni», d'intorno al 1913-14, e alla
Signora in giardino (ora nella Galleria Fiorentina
d'Arte Moderna); alla Cucitrice, ai due piccoli
capolavori: Anna che legge e Maria (1921); al
grande Nudo disteso (1922), e alla Colazione in
campagna, dipinta l'estate del 1924, nella Villa
Torlonia a Poli, e ormai sotto l'ombra della morte.
Questo materiale fu già, parzialmente, illustrato, nelle
pubblicazioni che allo Spadini dedicarono l'Ojetti, l'Oppo,
il Colasanti, il Soffici e il Mariani
(1); e forma il nucleo della «quadreria»
che, frattanto, vorremmo considerare nelle altre opere
ch'essa aduna: di italiani e stranieri; in special modo,
pittori della nostra seconda metà dell'Ottocento. E quando
avremo ricordato Spadini nel Mosè salvato dalle acque
(m. 2,67 X2,13), che rappresenta il suo massimo sforzo di
composizione, cui egli era venuto, dal 1911, preparandosi
con il primo Mosè (ora nella raccolta Bastianelli):
con un altro, pure di gran superficie, distrutto; e, al
Mosè (pagg. 705-707), avremo aggiunto: Bimbi al sole
(pag. 709), una delle sue tele di luminosità più robusta ed
equilibrata; e, con qualche altro saggio delle cose
«minori», la magica Bambina tra le corolle (pag.
706); non sarà che un minimo omaggio ad un'arte ch'è vanto
di scrittori di Dedalo avere, da anni lontani,
esaltata; e che questa collezione documenta in ogni periodo
del suo sviluppo: dallo spagnuolesco ritratto della
Fidanzata a quello della Madre (1907); alle
Tre età e all'Autoritratto con la moglie (1910);
alle «conversazioni», d'intorno al 1913-14, e alla
Signora in giardino (ora nella Galleria Fiorentina
d'Arte Moderna); alla Cucitrice, ai due piccoli
capolavori: Anna che legge e Maria (1921); al
grande Nudo disteso (1922), e alla Colazione in
campagna, dipinta l'estate del 1924, nella Villa
Torlonia a Poli, e ormai sotto l'ombra della morte.
|

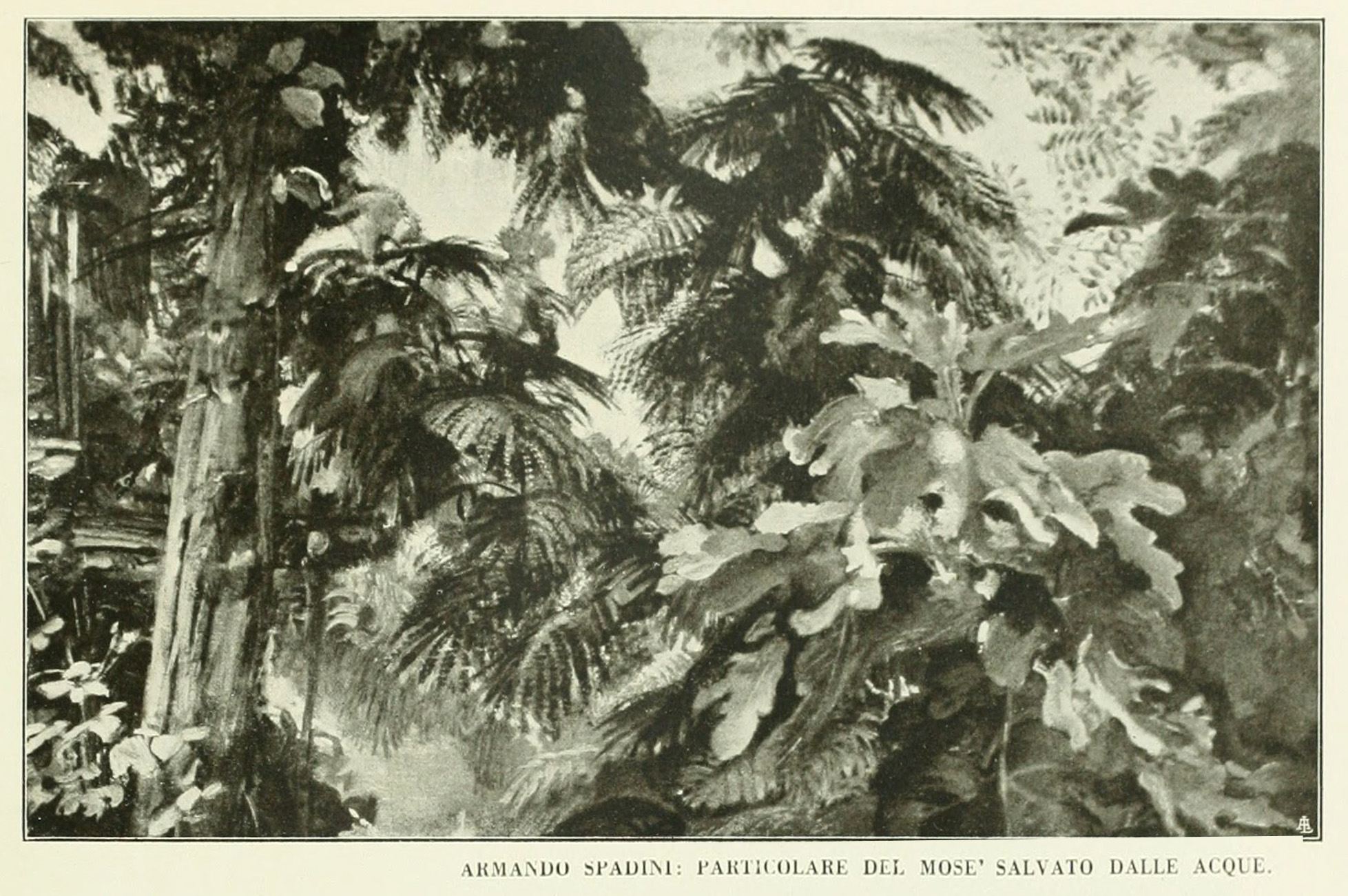 Da circa un ventennio il Fiano raccoglie pitture e qualche
scultura. E la sua collezione è stata creata di pianta;
intendo che non cresce sopra un vecchio fondo ereditario.
Non si mancano al tutto gli antichi (senesi, Guercino,
Baroccio, Piazzetta, alcuni fiamminghi, ecc.); ma, come s'è
notato, il principale interesse le proviene dalla nostra
arte ottocentesca. L'aspetto della raccolta ritiene del modo
con il quale essa è venuta formandosi; e, fra il migliaio di
pezzi che a tutt'oggi la costituiscono, un'indagine
rigorosa, intralciata per ora dall'ammassamento, è probabile
che darebbe risalto ad altre opere, oltre a quelle sulle
quali, in una frequenza ormai abbastanza lunga, si fissò la
nostra attenzione. Alcune di queste ultime ci hanno già
servito, su queste stesse pagine e altrove
(2), trattando di pittura
dell'Ottocento. E riferendoci, quando non occorra di più, a
cotesti scritti, tocchiamo, brevemente, di altri dipinti;
che raduneremo, per comodo d'esame, sotto i tre canoni:
toscano, napoletano e lombardo.
Da circa un ventennio il Fiano raccoglie pitture e qualche
scultura. E la sua collezione è stata creata di pianta;
intendo che non cresce sopra un vecchio fondo ereditario.
Non si mancano al tutto gli antichi (senesi, Guercino,
Baroccio, Piazzetta, alcuni fiamminghi, ecc.); ma, come s'è
notato, il principale interesse le proviene dalla nostra
arte ottocentesca. L'aspetto della raccolta ritiene del modo
con il quale essa è venuta formandosi; e, fra il migliaio di
pezzi che a tutt'oggi la costituiscono, un'indagine
rigorosa, intralciata per ora dall'ammassamento, è probabile
che darebbe risalto ad altre opere, oltre a quelle sulle
quali, in una frequenza ormai abbastanza lunga, si fissò la
nostra attenzione. Alcune di queste ultime ci hanno già
servito, su queste stesse pagine e altrove
(2), trattando di pittura
dell'Ottocento. E riferendoci, quando non occorra di più, a
cotesti scritti, tocchiamo, brevemente, di altri dipinti;
che raduneremo, per comodo d'esame, sotto i tre canoni:
toscano, napoletano e lombardo.
|
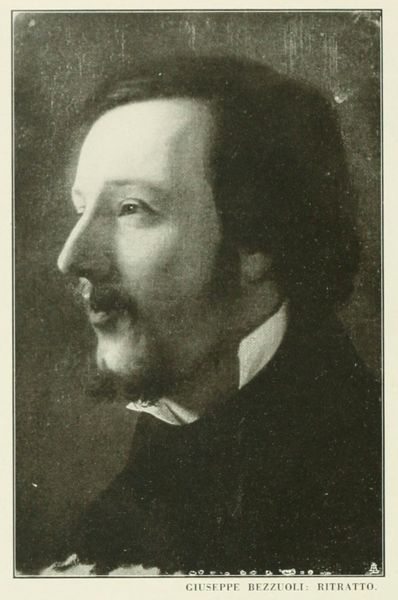
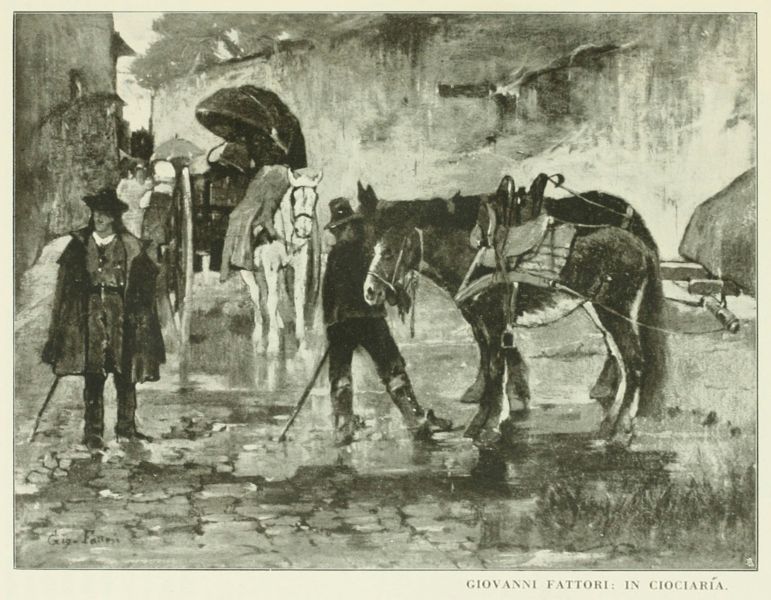 Al lettore che ricorda un doppio ritratto I fidanzati,
eseguito da Giovanni Fattori intorno al 1864, e la prima
volta pubblicato qui sopra
(3), questa testa di Giuseppe Bezzuoli
(pag. 710) si presenta con un'aria di conoscenza; tant'è
simile l'artifizio chiaroscurale, inteso a risolvere
geometricamente la forma. Il Bezzuoli è più sfumato e molle;
ma nella crudezza fattoriana, che annuncia tutt'altra stoffa
di pittore, è la traccia d'un tirocinio che, se non deve
sopravalutarsi, neppure deve essere del tutto trascurato. E
un'altra vecchia conoscenza è il buttero o «trainiero» col
pastrano, nella tavoletta fattoriana (già della Galleria
Pisani): In Ciociarìa (pag. 711). Forse si tratta
della prima notazione d'un personaggio che l'artista mise,
più in grande, a muro della Sosta (raccolta
Checcucci). E il carretto col cavallo bianco, su uno sfondo
di straducce campestri lavate dall'acquazzone, sta a
confronto con quelli del Riposo
nella Galleria Fiorentina.
Al lettore che ricorda un doppio ritratto I fidanzati,
eseguito da Giovanni Fattori intorno al 1864, e la prima
volta pubblicato qui sopra
(3), questa testa di Giuseppe Bezzuoli
(pag. 710) si presenta con un'aria di conoscenza; tant'è
simile l'artifizio chiaroscurale, inteso a risolvere
geometricamente la forma. Il Bezzuoli è più sfumato e molle;
ma nella crudezza fattoriana, che annuncia tutt'altra stoffa
di pittore, è la traccia d'un tirocinio che, se non deve
sopravalutarsi, neppure deve essere del tutto trascurato. E
un'altra vecchia conoscenza è il buttero o «trainiero» col
pastrano, nella tavoletta fattoriana (già della Galleria
Pisani): In Ciociarìa (pag. 711). Forse si tratta
della prima notazione d'un personaggio che l'artista mise,
più in grande, a muro della Sosta (raccolta
Checcucci). E il carretto col cavallo bianco, su uno sfondo
di straducce campestri lavate dall'acquazzone, sta a
confronto con quelli del Riposo
nella Galleria Fiorentina.
|
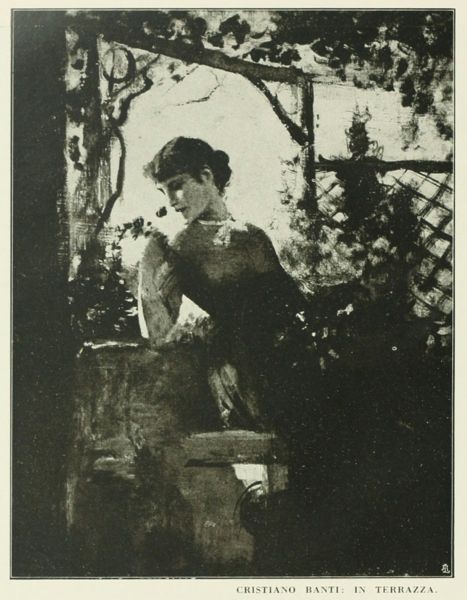
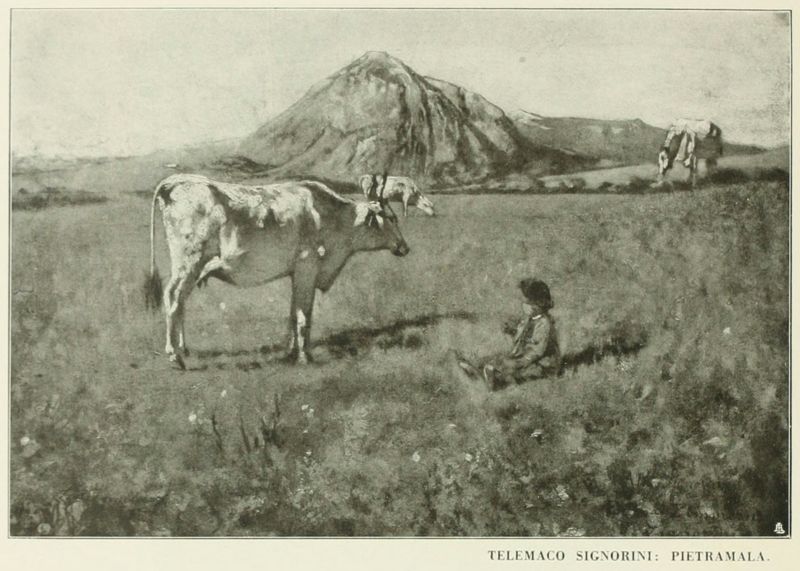 Per ragioni che varrebbe la pena di definire, l'afflusso a
Roma d'opere di «macchiajuoli», e, in genere, toscani
dell'ultimo secolo, fu, e si mantiene, minore di quello
d'opere napoletane, ed anche venete e lombarde. Comunque,
nella raccolta Fiano, Cristiano Banti è squisitamente
rappresentato (pag. 712). Vito d'Ancona, fra l'altro, ha un
acre ritrattino
(4); e un abbozzo di figura muliebre
che, insieme alla Signora con l'ombrellino della
raccolta Checcucci, sembra, con la sua pennellata verticale,
e l'allungamento delle forme, prestar buoni argomenti per la
sicura attribuzione di quell'importantissitlio bozzetto:
Le corse alle Cascine, esposto ultimamente alla
«Fontanesi» di Torino, e supposto del d'Ancoia, ma con
alquanti dubbi e reticenze. V'è poi insieme ad altri piccoli
paesi, e a un delicatissitmo ritrattino della Nenè,
lo studietto: Pietramala di Telemaco Signorini (pag.
714). È dedicato ad Helen Zimmern, uno dei più strani tipi
di intellettuali stranieri, fattisi quasi fiorentini
d'elezione e residenza; conoscente e corrispondente di
Nietzsche, Wagner, Boeklin, Liszt; ed oltre alla freschezza
pittorica, ha la piccola curiosità d'un documento delle
amicizie che il Signorini coltivava sulle zone di frontiera
internazionale, donde potesse giungere qualche accenno di
cultura
(5).
Per ragioni che varrebbe la pena di definire, l'afflusso a
Roma d'opere di «macchiajuoli», e, in genere, toscani
dell'ultimo secolo, fu, e si mantiene, minore di quello
d'opere napoletane, ed anche venete e lombarde. Comunque,
nella raccolta Fiano, Cristiano Banti è squisitamente
rappresentato (pag. 712). Vito d'Ancona, fra l'altro, ha un
acre ritrattino
(4); e un abbozzo di figura muliebre
che, insieme alla Signora con l'ombrellino della
raccolta Checcucci, sembra, con la sua pennellata verticale,
e l'allungamento delle forme, prestar buoni argomenti per la
sicura attribuzione di quell'importantissitlio bozzetto:
Le corse alle Cascine, esposto ultimamente alla
«Fontanesi» di Torino, e supposto del d'Ancoia, ma con
alquanti dubbi e reticenze. V'è poi insieme ad altri piccoli
paesi, e a un delicatissitmo ritrattino della Nenè,
lo studietto: Pietramala di Telemaco Signorini (pag.
714). È dedicato ad Helen Zimmern, uno dei più strani tipi
di intellettuali stranieri, fattisi quasi fiorentini
d'elezione e residenza; conoscente e corrispondente di
Nietzsche, Wagner, Boeklin, Liszt; ed oltre alla freschezza
pittorica, ha la piccola curiosità d'un documento delle
amicizie che il Signorini coltivava sulle zone di frontiera
internazionale, donde potesse giungere qualche accenno di
cultura
(5).
|
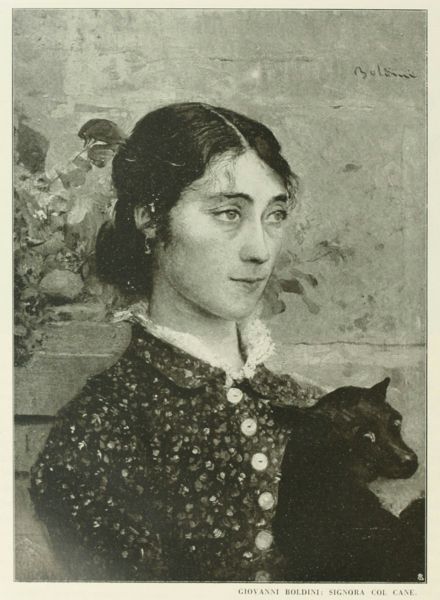
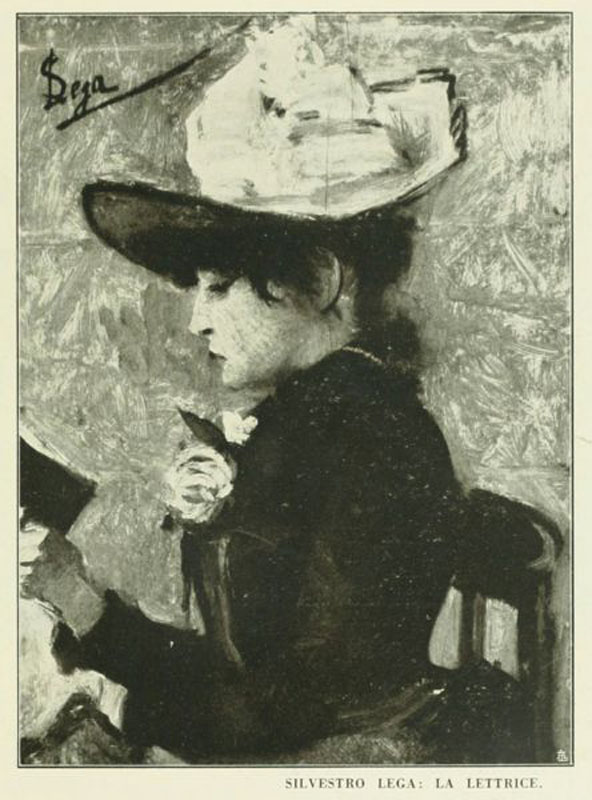 Di Silvestro Lega, insieme ad una delle Bandini che legge
(pag. 713; 1887) e, all'incirca della stessa epoca, la
Signora che ricama in giardino, è l'ovale d'una testa
femminile del periodo, invece, formativo. E non ripeteremo
qui l'illustrazione d'un bozzetto, Posa in studio, il
quale comprova il vivace influsso della pittura veneta su
Antonio Puccinelli, e il culto di questi per l'arte del
Morelli; mentre un paesaggio su tavola, Villa Petrocchi
(detto anche: Spedaletto) d'intorno al 1870, proveniente
dalla raccolta Ruffino, esprime come meglio non si potrebbe,
il Puccinelli che risolve il proprio eclettismo nella
riforma toscana: in parte preparandone alcuni aspetti, in
parte derivandone. La qualità dei verdi, osservò già il
Panichi
(6), fa pensare al Cannicci.
Di Silvestro Lega, insieme ad una delle Bandini che legge
(pag. 713; 1887) e, all'incirca della stessa epoca, la
Signora che ricama in giardino, è l'ovale d'una testa
femminile del periodo, invece, formativo. E non ripeteremo
qui l'illustrazione d'un bozzetto, Posa in studio, il
quale comprova il vivace influsso della pittura veneta su
Antonio Puccinelli, e il culto di questi per l'arte del
Morelli; mentre un paesaggio su tavola, Villa Petrocchi
(detto anche: Spedaletto) d'intorno al 1870, proveniente
dalla raccolta Ruffino, esprime come meglio non si potrebbe,
il Puccinelli che risolve il proprio eclettismo nella
riforma toscana: in parte preparandone alcuni aspetti, in
parte derivandone. La qualità dei verdi, osservò già il
Panichi
(6), fa pensare al Cannicci.
Ma né il Cannicci, né forse lo stesso Lega, ebbero mai
visione paesistica di così tranquilla ed ariosa robustezza.
E includendo, almeno per il periodo che nella sua produzione
più ci interessa, fra i toscani, il Boldini, con una scena
di fanciulli, che risente del Banti, ma più irritata; ecco
la testina di Signora col cane (pag. 716), d'una
definizione stridula e pungente. Un Boldini già in parte
uscito dall'assetto macchiaiolo; ma ancor lontano dal
mirabile monstrum
che doveva dar tanto filo da torcere ai più indiavolati
prestigiatori della ritrattistica mondiale.
Tutto il contorno d'opere e opericciuole di minori, che, in
ogni raccolta, completa il quadro d'una scuola pittorica,
come i ninnoli e i piccoli bronzi sui mobili completano
l'arredo d'un salotto, sfugge, necessariamente, a un
resoconto che non ha pretese di catalogo. E il Corcos, pur
con un ritratto, del 1882, da far ricredere quanti giudicano
di lui troppo sbrigatamente; l'Ussi, Francesco Gioli, Tito
Conti, il Focardi, il Cannicci, Plinio Nomellini, ecc.,
ecc., ci convien lasciarli con quei napoletani, ed altri
meridionali: Ponticelli, Cammarano, Tofano, Dalbono, De
Nittis, Lojacono, ecc. che, offerti in modo assai brillante,
fanno da accompagno ad alcuni fra i massimi pittori
dell'Ottocento partenopeo.
|
|
|
|
Continua - Pagina 2/2
|
|
|
|
|
|
|
|