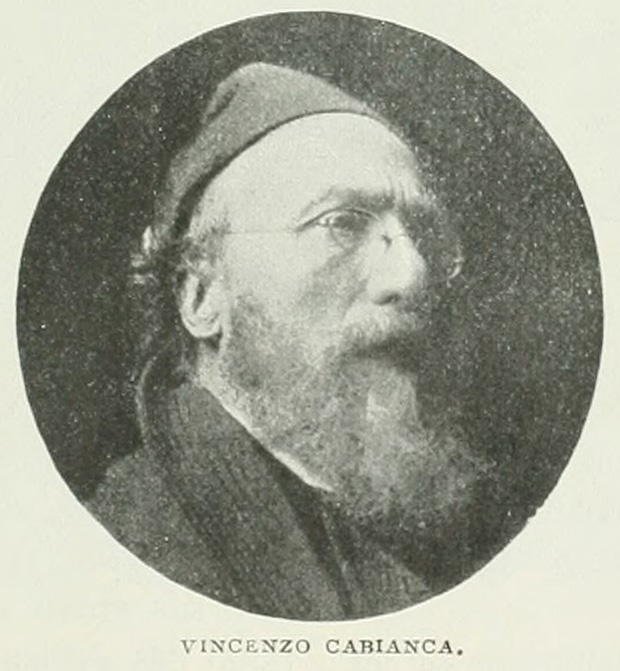 Vincenzo Cabianca si è spento serenamente in Roma il 21 di
marzo, come serenamente e onestamente aveva vissuto, modesto
ma tenace e glorioso odiatore di ogni accademismo ufficiale,
lavoratore coscientemente sdegnoso di ogni concessione alla
moda od al lucro, pittore genialissimo la cui memoria
vincerà il tempo e la cui opera è sicuro decoro della nuova
pittura italiana nella seconda metà del secolo XIX. Da più
anni una paralisi lo aveva fieramente colpito in tutto il
lato sinistro; ma poichè il male aveva quasi avuto rispetto
della mano operatrice, così egli, con opportune
modificazioni al cavalletto, non restò dal lavorare e dal
produrre opere veramente belle, come il suggestivo quadro
C'era una volta una chiesinain riva al mare, che alla
terza Mostra Veneziana apparve quasi una luminosa
affermazione di una forte e nuova giovinezza.
Vincenzo Cabianca si è spento serenamente in Roma il 21 di
marzo, come serenamente e onestamente aveva vissuto, modesto
ma tenace e glorioso odiatore di ogni accademismo ufficiale,
lavoratore coscientemente sdegnoso di ogni concessione alla
moda od al lucro, pittore genialissimo la cui memoria
vincerà il tempo e la cui opera è sicuro decoro della nuova
pittura italiana nella seconda metà del secolo XIX. Da più
anni una paralisi lo aveva fieramente colpito in tutto il
lato sinistro; ma poichè il male aveva quasi avuto rispetto
della mano operatrice, così egli, con opportune
modificazioni al cavalletto, non restò dal lavorare e dal
produrre opere veramente belle, come il suggestivo quadro
C'era una volta una chiesinain riva al mare, che alla
terza Mostra Veneziana apparve quasi una luminosa
affermazione di una forte e nuova giovinezza.
L'artista, innamorato della sua arte, non poteva morire
senza un sospiro per essa. L'ultimo quadro a cui attendeva
era un acquarello che egli desumeva, trasformandolo e
intensificandolo come di consueto, da una freschissima
impressione ritratta ad olio in Forio d'Ischia: un muro
abbagliante nel sole; l'ombra, davanti, di una croce
invisibile; dietro, il mare intensamente turchino aleggiato
da due veline bianche. L'acquarello, condotto già bene
innanzi, non aveva ancora i lievi tocchi delle vele di pace.
E mentre Carlo Ferrari — il diletto discepolo che ne ha
ritratte le dignitose sembianze in una calda e vigorosa tela
— gli chiudeva gli occhi velati alla luce, l'ultimo sospiro
del pittore fu ancora per l'arte, per le due veline bianche
mancanti al quadro!
|
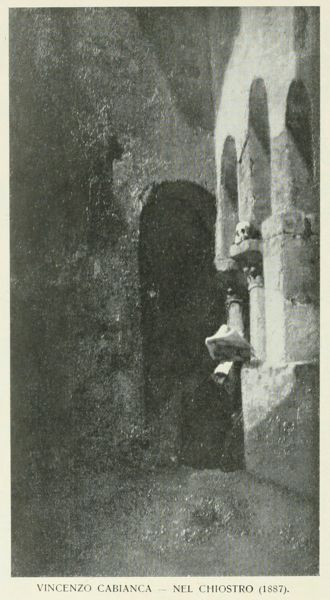
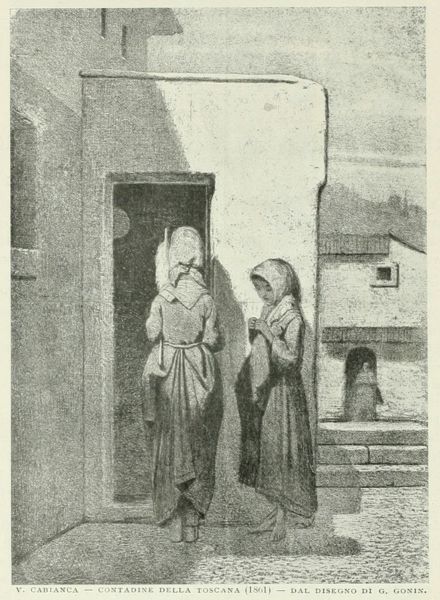 Era nato a Verona nel 1827; ma nella patria poco visse, come
poco studiò all'Accademia di Venezia, dove pur ottenne
qualche premio e frequentò a pena le classi, tanto per
essere mandato a far le vacanze a casa. I due periodi più
importanti della sua vita possono dirsi quello passato in
Toscana e l'altro a Roma. Il primo, di lotta, di battaglia,
di ricerche e di affermazione; il secondo, di raccoglimento
pensoso e tenace, di esplicazione completa delle sue
qualità. E però fu
macchiajolo e come tale visse in intima vita col Signorini, col Cecioni,
col Banti e specialmente con Nino Costa: amicizie cordiali,
per quanto all'apparenza turbate da qualche nuvola, che
mantenne sino alla morte.
Era nato a Verona nel 1827; ma nella patria poco visse, come
poco studiò all'Accademia di Venezia, dove pur ottenne
qualche premio e frequentò a pena le classi, tanto per
essere mandato a far le vacanze a casa. I due periodi più
importanti della sua vita possono dirsi quello passato in
Toscana e l'altro a Roma. Il primo, di lotta, di battaglia,
di ricerche e di affermazione; il secondo, di raccoglimento
pensoso e tenace, di esplicazione completa delle sue
qualità. E però fu
macchiajolo e come tale visse in intima vita col Signorini, col Cecioni,
col Banti e specialmente con Nino Costa: amicizie cordiali,
per quanto all'apparenza turbate da qualche nuvola, che
mantenne sino alla morte.
Firenze non fu il solo centro della sua giovanile attività,
fatta di sdegno contro ogni convenzionalismo e di conquista
ed interpretazione del vero. Poichè fin d'allora si può dire
che i suoi lavori (e la Mandriana e il Porcile al
sole
del '60 ne furono saggi arditissimi) fossero essenzialmente
informati da quei due grandi principii del valore e
del
rapporto, che costituivano certamente il trionfo della nova scuola.
Così dopo aver vissuto qualche tempo alla Spezia e a
Pietravigne, fu a Parigi col Signorini e col Banti; e
tornato in Italia si condusse a Parma, dove nel 1864 si
ammogliò, ma non restò a lungo, poichè già nel 1868 lo
troviamo a Roma. Quivi rimase e fissò la sua dimora, che
lasciò solo ne mesi estivi per la villeggiatura a
Castiglioncello (dove si recò per nove anni consecutivi), e
poi a Rocca di Papa.
|
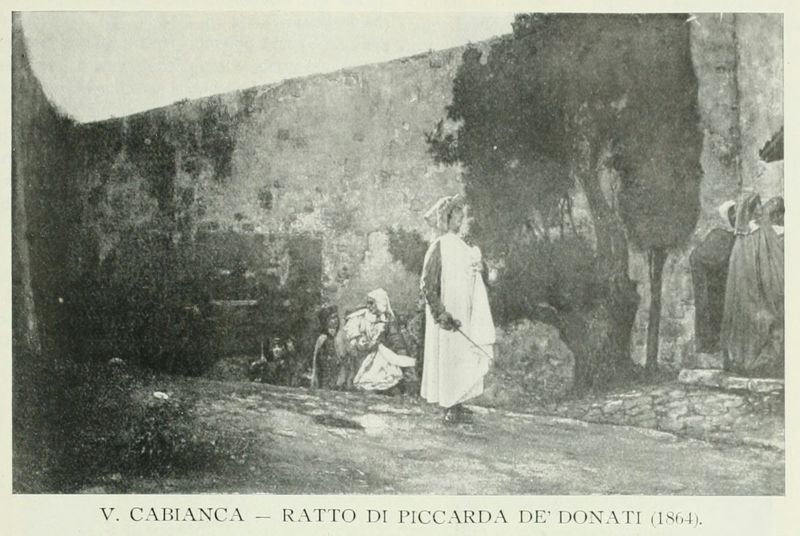
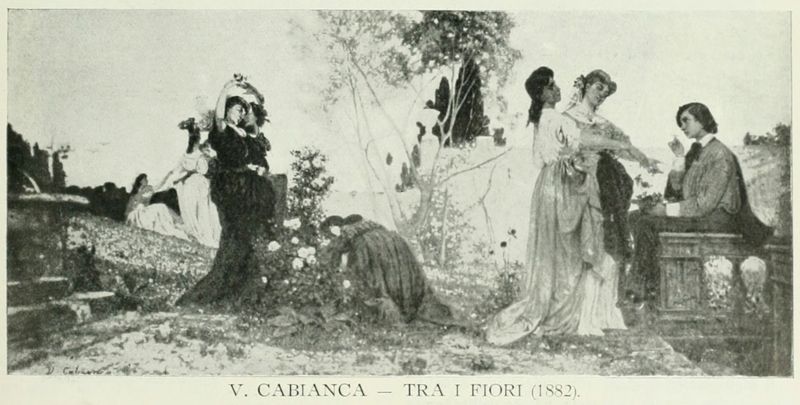 Il suo arrivo a Firenze è molto briosamente descritto da
Adriano Cecioni in un numero (12 luglio 1885) della
Domenica del Fracassa. E ci par proprio di vederlo
«giovinetto snello - nell'inverno del 1853 - di statura
giusta, vestito molto pulitamente, con un piccolo cappello,
un giubbino corto e i pantaloni a coscia» girar per Borgo la
Croce in cerca di un pittore, Giovanni Signorini. Ma al
Caffè dell'Onore, invece del padre pittore delle feste
granducali, trovò il figliolo Telemaco e il Borrani. Da
buoni amici si conobbero e si vollero bene e da questa
amicizia derivò anche una trasformazione completa nello
spirito artistico del giovane, che erasi recato a Firenze,
come attratto da un bisogno di novità ideali irresistibile.
Il suo arrivo a Firenze è molto briosamente descritto da
Adriano Cecioni in un numero (12 luglio 1885) della
Domenica del Fracassa. E ci par proprio di vederlo
«giovinetto snello - nell'inverno del 1853 - di statura
giusta, vestito molto pulitamente, con un piccolo cappello,
un giubbino corto e i pantaloni a coscia» girar per Borgo la
Croce in cerca di un pittore, Giovanni Signorini. Ma al
Caffè dell'Onore, invece del padre pittore delle feste
granducali, trovò il figliolo Telemaco e il Borrani. Da
buoni amici si conobbero e si vollero bene e da questa
amicizia derivò anche una trasformazione completa nello
spirito artistico del giovane, che erasi recato a Firenze,
come attratto da un bisogno di novità ideali irresistibile.
Il Signorini ed il Borrani che da prima stupivano nel
guardare la pittura di lui superficiale e scolastica,
ricamata
con molta tinta, all'uso dell'Induno, «con dei bioccolini e
delle polpettine di colore che metteva via via su la tela
con la punta del pennello», non poterono tardare ad
ammirarne la evoluzione verso le loro ricerche, anzi a
riconoscerlo come il più appassionato e violento dei
novatori.
|
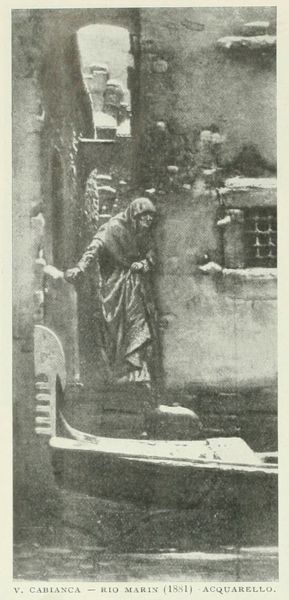
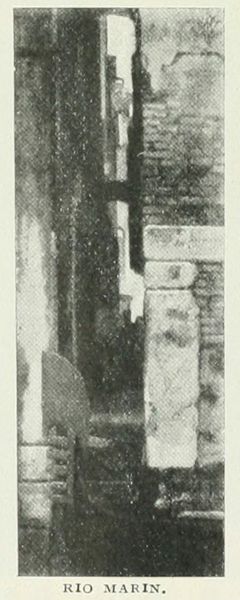
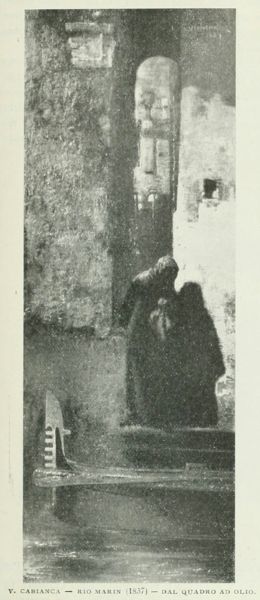 Compresa la ragione dei rapporti e dei valori, egli la
espresse con effetti di chiaroscuro che più che arditi
dovevano dirsi prepotenti. Però lo stesso Cecioni ne avverte
che se la natura lo avesse aiutato a vedere più giustamente
il colore, avrebbe potuto persuadere chiunque che la
macchia è fondamento vero della pittura.
Compresa la ragione dei rapporti e dei valori, egli la
espresse con effetti di chiaroscuro che più che arditi
dovevano dirsi prepotenti. Però lo stesso Cecioni ne avverte
che se la natura lo avesse aiutato a vedere più giustamente
il colore, avrebbe potuto persuadere chiunque che la
macchia è fondamento vero della pittura.
Bisogna notare che questa osservazione è fatta da un
macchiajolo fervente, già degno del plauso di G. Carducci,
oltre un quarto di secolo dopo che il principio e la
combriccola poterono affermarsi e trionfare della vieta e
stenta accademia, della fredda rigidezza della linea, della
ricerca sonora del soggetto pel soggetto.
(1)
Però non crediamo inutile insistere su quello che veramente
i migliori di essi intesero per macchia ed anche non
intesero. Poichè la morte di Vincenzo Cabianca ci rende più
liberi e disinvolti nel tributargli encomio altissimo non
solo pel verace valore delle sue ricerche serene e vivide,
ma anche per la fedele costanza con cui svolse — si può dire
fino all'ultima agonia — i principii di battaglia
animosamente accolti e perseguiti da giovane.
|

 Molti macchiajoli crederono che macchia volesse dire
abbozzo e che lo studio delle gradazioni e delle parti
nella parte, servendo a rendere quest'abbozzo finito,
bandisse la macchia dal quadro. Invece la macchia è
base, e come tale deve restare nel quadro, senza che i
particolari formali la distruggano o rendano trita. Poichè
il vero resulta agli occhi da macchie di colore e di
chiaroscuro, ciascuna delle quali ha un valore proprio che
si misura col rapporto. Ma il vero nodo della questione e
della fede dei giovani artisti italiani era in questo: che
il chiaroscuro avesse una parte primaria ed assoluta, e il
colorito secondaria e subordinata. L'errore era nel credere
che si dovesse sacrificare l'uno all'altro; come pure
errarono quei macchiajoli che, ignorando la legge del
colore integralmente eguale a se stesso, lo distinsero in
due differenti, quando ebbero a dipingere un muro o una
strada metà in luce e metà in ombra.
Molti macchiajoli crederono che macchia volesse dire
abbozzo e che lo studio delle gradazioni e delle parti
nella parte, servendo a rendere quest'abbozzo finito,
bandisse la macchia dal quadro. Invece la macchia è
base, e come tale deve restare nel quadro, senza che i
particolari formali la distruggano o rendano trita. Poichè
il vero resulta agli occhi da macchie di colore e di
chiaroscuro, ciascuna delle quali ha un valore proprio che
si misura col rapporto. Ma il vero nodo della questione e
della fede dei giovani artisti italiani era in questo: che
il chiaroscuro avesse una parte primaria ed assoluta, e il
colorito secondaria e subordinata. L'errore era nel credere
che si dovesse sacrificare l'uno all'altro; come pure
errarono quei macchiajoli che, ignorando la legge del
colore integralmente eguale a se stesso, lo distinsero in
due differenti, quando ebbero a dipingere un muro o una
strada metà in luce e metà in ombra.
La macchia dunque voleva essere considerata come
scienza e non come abbozzo: come scienza e mezzo di
sorprendere la natura com'è in uno de' suoi infiniti
momenti, addestrando la mano a fissare rapidamente l'effetto
complessivo, rigettando ogni sussidio di matita od altro.
|
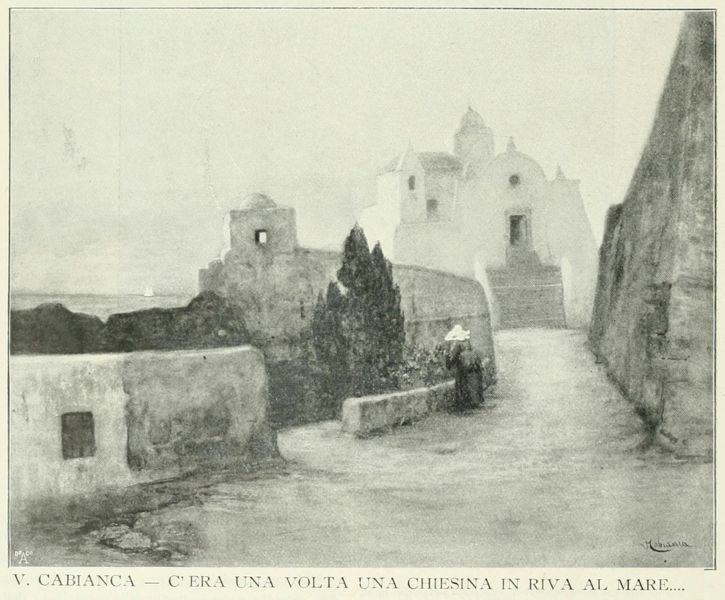
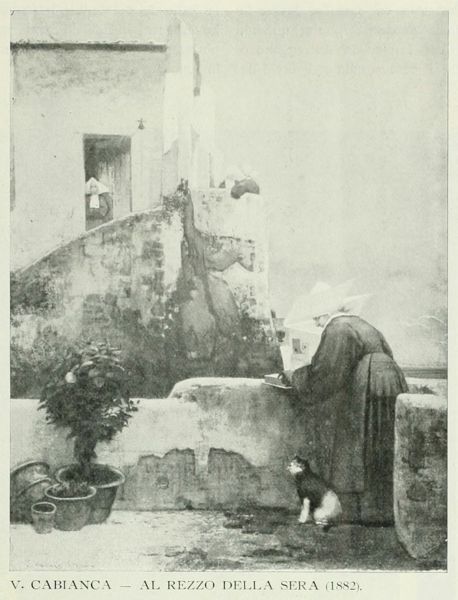 Ma se altri deviarono, feroce fu la passione con cui il
Cabianca attuò e proseguì il nuovo ideale. - Nel palazzo
comunale di Firenze, è ora visibile a tutti un quadro del
nostro pittore, che rimonta al 1868 ed è forse, e non solo
per le dimensioni, la tela più importante della raccolta che
Diego Martelli, l'amico e il critico geniale dei
Macchiajoli, ha legata alla città di Firenze. S'intitola
semplicemente Bagno fra gli scogli ed è tutta un
contrasto di luci e di ombre profonde. Contro il cielo
solcato di grandi nuvole bianche e che appare più luminoso
per l'opposizione degli scogli foschi ed angolosi, due nude
e bronzee femmine si staccano; l'una ci volge il tergo nudo,
l'altra si reca il lenzuolo al seno e ride nel fissare la
compagna sdraiata e seminuda scherzante col suo bambino.
Ma se altri deviarono, feroce fu la passione con cui il
Cabianca attuò e proseguì il nuovo ideale. - Nel palazzo
comunale di Firenze, è ora visibile a tutti un quadro del
nostro pittore, che rimonta al 1868 ed è forse, e non solo
per le dimensioni, la tela più importante della raccolta che
Diego Martelli, l'amico e il critico geniale dei
Macchiajoli, ha legata alla città di Firenze. S'intitola
semplicemente Bagno fra gli scogli ed è tutta un
contrasto di luci e di ombre profonde. Contro il cielo
solcato di grandi nuvole bianche e che appare più luminoso
per l'opposizione degli scogli foschi ed angolosi, due nude
e bronzee femmine si staccano; l'una ci volge il tergo nudo,
l'altra si reca il lenzuolo al seno e ride nel fissare la
compagna sdraiata e seminuda scherzante col suo bambino.
Nessuna ricerca di linea bella; nè pure una gran sicurezza
di scorci; ma un violento gioco di luci che rivelano bene
l'innamorato del sole e la potenza coloristica della scuola
veneziana. Oltre questa tela, che pare non ottenesse il
favore che il pubblico pur concesse alle altre violente
ricerche al Mandriano e al Porcile al sole del
1860 ed alle Monachine del 1861 — nella stessa
raccolta si possono notare due studii molto più piccoli,
rappresentanti un pollaio e lo sfondo di un archivolto.
Benchè la impressione diretta del vero e la freschezza del
colore ce li rendano simpatici, essi sono la conferma delle
riserve già citate del Cecioni.
|
|
Continua - Pagina 2/2
|
|
|
|