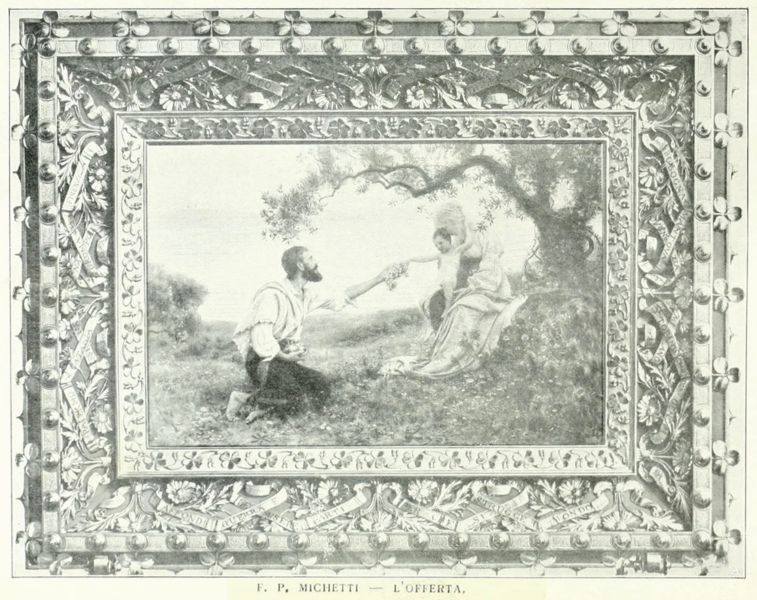 Nè l'influsso del Fortunv fu il solo influsso straniero
visibile allora nelle opere del Michetti. Da dieci anni, e
precisamente dall' esposizione internazionale del 1867,
Parigi aveva messo alla moda i chiari e capricciosi pittori
giapponesi e lo stesso Fortuny ne era stato incantato, ma
solo il gruppo intorno a Manet e a Degas aveva tratto da
quell'iniziazione vantaggi positivi e durevoli: la
limpidezza della colorazione, la vivacità nel cogliere
espressioni e movimenti fuggevoli, la libertà del comporre
equilibrando il quadro solo sopra un'armonia di colori e non
più sulla simmetria delle linee e sul contrappeso delle
Masse. Come era avvenuto ai fontanesiani piemontesi e ai
"Macchiajoli" fiorentini, che avevano studiato il paesaggio
inglese di Bonington e di Constable solo sui grandi paesisti
francesi del 1830, anche questa volta gl'italiani non videro
o almeno non capirono i giapponesi che attraverso al Fortuny
e, peggio, attraverso i suoi minori e sfarfalleggianti
seguaci. Fu un delirio: illustrazioni di libri, manifesti
murali, testate di giornali, copertine di romanze, mode
femminili, decorazioni di intere sale, tutto parve uscir dai
ventagli e dai paraventi e dalle false lacche dei bazar
giapponesi di Napoli e di Roma. E pittori di ventagli,
spesso come il Dalbono squisiti di brio, sorsero in ogni
angolo d'Italia, schiavi del Giappone in nome della libertà.
E in tutti quelli che vollero dirsi originali e moderni fu
presto visibile l'odio pel color mummia e per le così dette
"tinte sugose" d'una volta, la diffidenza pei gialli e
l'amor per la biacca, la ricerca della luce di faccia per
evitare più che fosse possibile le ombre, la passione pei
toni locali ed interi e, in conclusione, il deliberato
disdegno della prospettiva aerea, la mancanza di ogni
profondità, tutte le figure sullo stesso piano egualmente
chiare, dipinte a fior di tela. Son le parole di un pittore,
di Francesco Netti, scritte appunto per l'esposizione
napoletana del 1877 e del Corpus Domini di Francesco
Paolo Michetti.
Nè l'influsso del Fortunv fu il solo influsso straniero
visibile allora nelle opere del Michetti. Da dieci anni, e
precisamente dall' esposizione internazionale del 1867,
Parigi aveva messo alla moda i chiari e capricciosi pittori
giapponesi e lo stesso Fortuny ne era stato incantato, ma
solo il gruppo intorno a Manet e a Degas aveva tratto da
quell'iniziazione vantaggi positivi e durevoli: la
limpidezza della colorazione, la vivacità nel cogliere
espressioni e movimenti fuggevoli, la libertà del comporre
equilibrando il quadro solo sopra un'armonia di colori e non
più sulla simmetria delle linee e sul contrappeso delle
Masse. Come era avvenuto ai fontanesiani piemontesi e ai
"Macchiajoli" fiorentini, che avevano studiato il paesaggio
inglese di Bonington e di Constable solo sui grandi paesisti
francesi del 1830, anche questa volta gl'italiani non videro
o almeno non capirono i giapponesi che attraverso al Fortuny
e, peggio, attraverso i suoi minori e sfarfalleggianti
seguaci. Fu un delirio: illustrazioni di libri, manifesti
murali, testate di giornali, copertine di romanze, mode
femminili, decorazioni di intere sale, tutto parve uscir dai
ventagli e dai paraventi e dalle false lacche dei bazar
giapponesi di Napoli e di Roma. E pittori di ventagli,
spesso come il Dalbono squisiti di brio, sorsero in ogni
angolo d'Italia, schiavi del Giappone in nome della libertà.
E in tutti quelli che vollero dirsi originali e moderni fu
presto visibile l'odio pel color mummia e per le così dette
"tinte sugose" d'una volta, la diffidenza pei gialli e
l'amor per la biacca, la ricerca della luce di faccia per
evitare più che fosse possibile le ombre, la passione pei
toni locali ed interi e, in conclusione, il deliberato
disdegno della prospettiva aerea, la mancanza di ogni
profondità, tutte le figure sullo stesso piano egualmente
chiare, dipinte a fior di tela. Son le parole di un pittore,
di Francesco Netti, scritte appunto per l'esposizione
napoletana del 1877 e del Corpus Domini di Francesco
Paolo Michetti.
|
 Il quale da quel capriccio che era venuto di moda e che
corrispondeva tanto bene alla sua giovinezza, partì di corsa
per mostrare in altri cento modi la sua fantasia bizzarra.
Il modo più evidente furono le cornici dei quadri che egli
naturalmente eseguiva da sè. Quella del Corpus Domini
color di ferro, con una donna dipinta in alto avvolta in un
lungo lenzuolo e un bambino in braccio alla donna, e, sotto,
un uomo nudo e un disco d'ottone lucido con su una palla
nera, recava scarabei, stelle marine, rosarii, crocifissi,
discipline, scapolari in una confusione che voleva essere un
commento del quadro e quasi una raccolta dei più singolari
emblemi dell'anima abruzzese. E contro la cornice i critici
si scagliarono anche più ferocemente che contro il quadro e,
come sette anni dopo a Roma Nino Costa contro il Voto,
i più feroci furono fin d'allora gli artisti che scrivevano
d'arte, Camillo Boito e Adriano Cecioni.
Il quale da quel capriccio che era venuto di moda e che
corrispondeva tanto bene alla sua giovinezza, partì di corsa
per mostrare in altri cento modi la sua fantasia bizzarra.
Il modo più evidente furono le cornici dei quadri che egli
naturalmente eseguiva da sè. Quella del Corpus Domini
color di ferro, con una donna dipinta in alto avvolta in un
lungo lenzuolo e un bambino in braccio alla donna, e, sotto,
un uomo nudo e un disco d'ottone lucido con su una palla
nera, recava scarabei, stelle marine, rosarii, crocifissi,
discipline, scapolari in una confusione che voleva essere un
commento del quadro e quasi una raccolta dei più singolari
emblemi dell'anima abruzzese. E contro la cornice i critici
si scagliarono anche più ferocemente che contro il quadro e,
come sette anni dopo a Roma Nino Costa contro il Voto,
i più feroci furono fin d'allora gli artisti che scrivevano
d'arte, Camillo Boito e Adriano Cecioni.
Per quella moda del Giappone l'Italia rischiò addirittura di
perdere il suo Michetti. Nel settembre del 1878 Antonio
Fontanesi aveva, dopo meno di due anni, lasciato la cattedra
di pittura all'Accademia di Tochio e se ne era tornato a
Torino pel conforto degli amici e dei discepoli che il gran
pubblico l'ignorava. Michetti andando ancora una volta a
Parigi si fermò a Torino e andò col De Amicis a trovarlo, e
il Fontanesi gli fece grandi lodi del Giappone, tanto che
Michetti tornò difilato a Roma e preparò i documenti pel
concorso alla cattedra lasciata libera dal Fontanesi e li
presentò alla legazione giapponese. Re Umberto era salito al
trono da pochi mesi. Una mattina Michetti incontrò un
generale, amico suo e ajutante di campo del re, che gli
consigliò d'andare, prima di partire, a salutare il sovrano.
Michetti accettò e mandò a stirare e a smacchiare la sua
marsina. La marsina non era tornata quando giunse l'invito
nel giorno stesso, al tocco. Ed ecco il pittore partire,
invece che pel Giappone, alla ricerca della sua marsina. La
trova dalla stiratrice, appesa alla finestra, stillante
d'acqua, che la brava donna aveva pensato, per smacchiarla,
di lavarla tutta.
|
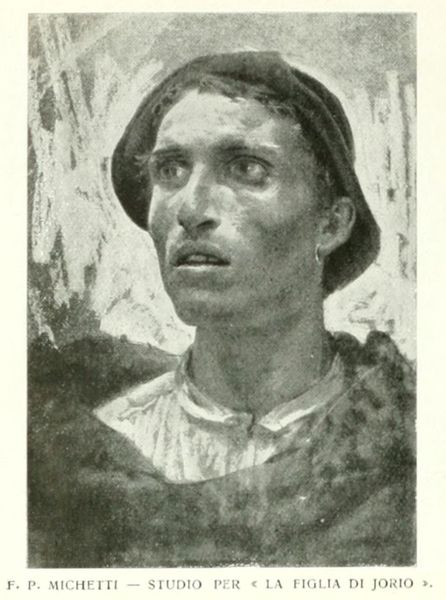 Michetti l'afferra bagnata com'è, corre a casa, la asciuga
al fuoco come può, e se l'infila che fumava e i calzoni gli
arrivavano a mezza gamba e le falde sembravano due cenci.
Tira di qua, tira di là, arrivò al Quirinale in un tale
stato che in anticamera i domestici gli domandarono il nome
della società operaia da lui rappresentata. Fu introdotto
dal re. Bisogna vedere e udite Michetti raccontare quel
colloquio roteando gli occhi per imitare lo sguardo fiero di
Umberto, e stirandosi colle due mani sul ventre il panciotto
bagnato per fargli raggiungere la cintola dei calzoni : "—
Voi, Michetti, proprio voi volete andare al Giappone ? -
Maestà, vi lavorerò molto bene. - Michetti, voi non dovete
andare laggiù. Il vostro posto è qui".
Michetti l'afferra bagnata com'è, corre a casa, la asciuga
al fuoco come può, e se l'infila che fumava e i calzoni gli
arrivavano a mezza gamba e le falde sembravano due cenci.
Tira di qua, tira di là, arrivò al Quirinale in un tale
stato che in anticamera i domestici gli domandarono il nome
della società operaia da lui rappresentata. Fu introdotto
dal re. Bisogna vedere e udite Michetti raccontare quel
colloquio roteando gli occhi per imitare lo sguardo fiero di
Umberto, e stirandosi colle due mani sul ventre il panciotto
bagnato per fargli raggiungere la cintola dei calzoni : "—
Voi, Michetti, proprio voi volete andare al Giappone ? -
Maestà, vi lavorerò molto bene. - Michetti, voi non dovete
andare laggiù. Il vostro posto è qui".
Michetti non volle udir altro. In fondo le parole del re
gliele diceva già da molti giorni il suo cuore. Tornò a
casa, regalò a qualcuno la sua marsina grinzosa, e restò in
Italia. Al Giappone andò l'altro concorrente, un pittore
Sangiovanni.
Così Michetti potè concorrere alle esposizioni di Torino del
1880 e di Milano del 1881. Furono quelle le prime prove in
cui egli si misurò coi più austeri pittori settentrionali,
col Bianchi, col Carcano, col Fontanesi il quale a Torino
esponeva le Nubi e parve che nessuno, nè giurie nè
pubblico, se ne avvedesse. E al romor del successo anche
quelle prove sembrarono riuscir fortunatissime per Michetti.
A Torino esponeva tutte pitture ad olio, i Pescatori di
Ondine, i Morticini, la Domenica delle Palme
che era quasi una variante del Corpus Domini, L'Impressione
sull'Adriatico che è rimasta una delle sue marine più
schiette e luminose su quel mare senza tramonti, infine l'Ottava
che fu subito comprata dal re. A Milano espose trentaquattro
quadri - teste e paesi - e la maggior parte era dipinta a
pastello e a tempera. Le teste eran quasi tutte teste di
giovani contadine dalle gote sode, dai capelli lisci, dalle
labbra tumide, dalle orecchie rosee ornate spesso da grandi
cerchi d'oro, campioni di salute e di gioventù, grandi
spesso quanto il vero, così che sembravano, strette nella
cornice, anche più grandi del vero, un po' sorde di luce o
almeno tutte dipinte sotto un'uguale luce di studio senza
che mai l'aria aperta dei loro campi le avvolgesse e le
animasse, ravvivate solo da qualche sfrego di colori
violenti. un giallo, un rosso, un cobalto sul fondo o nello
scialle sul seno, ma modellate, pareva, a colpi di pollice e
quasi scolpite. Furon vendute tutte nei primi giorni e
riprodotte tutte coi pochi processi fotomeccanici che allora
venivan di moda e imitate e falsificate all'infinito. La
casa Danesi ne fece tutt'un album.
|
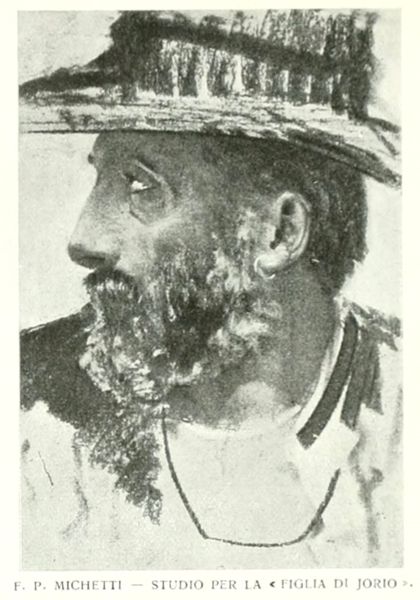 E poichè in quelli anni, in mezzo al così detto agone
letterario balzava, anch'egli ridendo di sincerissima gioia,
Gabriele d'Annunzio appena ventenne (Primo vere
usciva nell'80 e la prima grande edizione sommarughiana del
Canto novo composto « tra l'apide del 1881 e l'aprile
del 1882 » era illustrata con disegni di Michetti), quelle
belle donne parvero le muse contadine del nuovo poeta e la
E poichè in quelli anni, in mezzo al così detto agone
letterario balzava, anch'egli ridendo di sincerissima gioia,
Gabriele d'Annunzio appena ventenne (Primo vere
usciva nell'80 e la prima grande edizione sommarughiana del
Canto novo composto « tra l'apide del 1881 e l'aprile
del 1882 » era illustrata con disegni di Michetti), quelle
belle donne parvero le muse contadine del nuovo poeta e la
. . . . bella frenante la foga de' lombi stupendi
tra le prunaje rosse giù per la china audace,
alta, schiuse le nari ferine a l'odor de la selva,
violata da'l sole, bella stornellatrice....
parve nello specchio poetico l'acceso riflesso d'un quadro
michettiano.
Nessuno dei molti critici e biografi di Gabriele d'Annunzio
— Croce, Morello, Borgese — ha ancora voluto studiare quanto
quel poeta tutto sensi che a vent'anni era già innamorato di
tutte le arti figurative e già riempiva dei loro ricordi i
suoi scritti, abbia dovuto, allora e poi, all'affettuosa
vicinanza del Michetti. Nei quadri del suo conterraneo già
celebre molte delle figure, delle scene,dei paesi d'Abruzzo
che egli poi descriveva, gli apparivano già imitate in opera
d'arte, cioè già definite nei loto caratteri essenziali e
ordinate in modo da produrre sul pubblico l'effetto voluto.
Certo egli già vedeva le cose con quella curiosità inesausta
che in arte è propria dei grandi descrittori di paese, da
Chateaubriand a Maupassant. Ma Michetti gl'insegnò a
guardarle. Non basta fermarsi alla somiglianza dei temi, dal
San Pantaleo alla Figlia di Jorio. Bisogna giungere più in fondo.
Vincenzo Morello ha pubblicato nel suo
Gabriele d'Annunzio alcune pagine d'un taccuino del poeta scritte appunto
tra il 1881 e il 1882: son tutte descrizioni di paese e son
tutte fatte col "delirio" coloristico del Michetti di quel
tempo, segnando i varii colori di ogni cosa, d'ogni vela,
d'ogni nuvola, d'ogni pianta, d'ogni foglia, con una mania
pittorica minuta e continua che è rara nei poeti.
|
 Lo stesso paesaggio visto da due persone diventa due
paesaggi, ma d'Annunzio allora vide il paesaggio ha Chieti e
Francavilla, dalle colline alle foci del Pescara,
esattamente come lo vide Michetti, si può dite con gli occhi
di lui. Poi anch'egli si fece più sobrio, più meditato e
acquistò in stile quel che perdette in foga. Ed anche
Michetti fece lo stesso. Così si può pensare che alla
trasformazione, alla semplificazione, direi alla
stilizzazione della pittura michettiana tra il 1883 e il
1895, tra il Voto e la Figlia di Jorio, abbia
a sua volta contribuito l'esempio di Gabriele d'Annunzio, il
quale ospite del Michetti scrisse a Francavilla, nel
Convento di Santa Maria Maggiore comprato dal pittore
proprio nel 1883, il Piacere (1884-1889), l'Innocente
(1890-1892) e buona parte di quel Trionfò della Morte
(1889-1894) che è appunto dedicato al Michetti con una
prefazione nella quale è detto:
Lo stesso paesaggio visto da due persone diventa due
paesaggi, ma d'Annunzio allora vide il paesaggio ha Chieti e
Francavilla, dalle colline alle foci del Pescara,
esattamente come lo vide Michetti, si può dite con gli occhi
di lui. Poi anch'egli si fece più sobrio, più meditato e
acquistò in stile quel che perdette in foga. Ed anche
Michetti fece lo stesso. Così si può pensare che alla
trasformazione, alla semplificazione, direi alla
stilizzazione della pittura michettiana tra il 1883 e il
1895, tra il Voto e la Figlia di Jorio, abbia
a sua volta contribuito l'esempio di Gabriele d'Annunzio, il
quale ospite del Michetti scrisse a Francavilla, nel
Convento di Santa Maria Maggiore comprato dal pittore
proprio nel 1883, il Piacere (1884-1889), l'Innocente
(1890-1892) e buona parte di quel Trionfò della Morte
(1889-1894) che è appunto dedicato al Michetti con una
prefazione nella quale è detto:
"Ti ho anche raccolta in più pagine, o Cenobiarca,
l'antichissima poesia di nostra gente: quella poesia che tu
primo comprendesti e che per sempre ami".
Ma torniamo all'esposizione di Milano del 1881. In quella
trentina di quadri e di quadretti era sempre la stessa
esuberanza, la stessa volontà di meravigliare, le stesse
giapponeserie un po' di maniera in cui ai salti acrobatici
di prospettiva lineare non corrispondeva sempre una educata
finezza di prospettiva aerea, le stesse cornici con stelle,
croci, fiori, rami di mandorlo e d'olivo che dalla cornice
passavano poi dipinti sullo stesso vetro davanti al quadro,
e sempre la stessa nativa strabiliarte facilità di dipingere
senza un'esitazione mai, una manualità così pronta, così
sagace, così gioiosa che moltiplicava nel pubblico il
diletto pel tema e pei festosi colori perchè gli faceva
quasi vedere di là dalla tela il volto ridente e spensierato
del pittore. E il tema era sempre chiaro e definito come in
un quadretto di genere, ma con pochi personaggi e con
un'evidenza e una naturalezza e una grazia ignote fino
allora a tutti i pittori di genere, fuorchè all'Indulto e al
Favretto: ad esempio una covata di pulcini che invade la
culla dove dorme un bel bimbo; un'altra covata di pulcini
che pigola sulla veste della madre inginocchiata presso la
culla del suo bimbo morto; una contadina fiorosa e ingemmata
seguita da due innamorati, uno magro e malinconico e uno
lieto che canta.
|
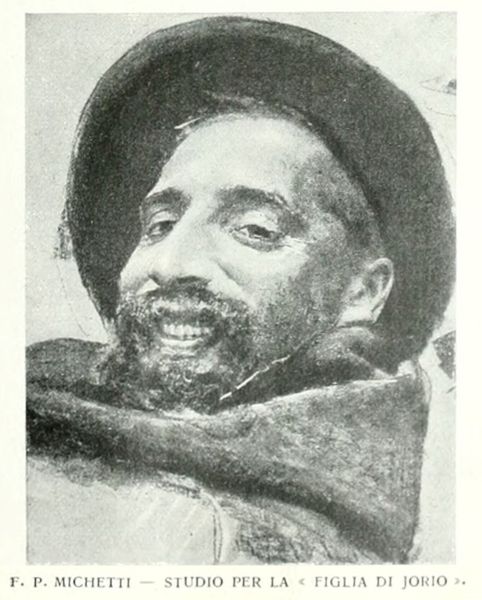 Il canto torna spesso in quelli anni, nei quadri dì
Michetti: è la voce stessa dell'anima sua. Una bella
contadina che in un paesaggio primaverile canta il suo amore
in faccia alla pianura o al mare, è il più somigliante e
sincero ritratto della sua arte. Per accompagnare le varie
voci di questo canto, quell'impetuoso indugia a scegliere i
gesti e i colori, e li dispone in fila conte un musicista
metterebbe le note più su o più giù, sulle cinque righe
della sua carta. Il primo studio delle sue Cinque ragazze
che cantano è un pastello sommario dove cinque ragazze
facendo catena con le belle braccia s'avanzaro sopra un
declivio che taglia la scena in diagonale; la traccia e in
nero lumeggiata da macchie di verde, d'azzurro e di bianco.
Ma poi il tema è semplificato in un altro abbozzo a bianco e
nero, con tre donne sole, separate, una a testa alta
lanciando il canto al cielo, il soprano, - una a testa più
bassa, il contralto, - una seria più indietro,
l'accompagnamento monocorde e fisso; e le loro braccia son
tese a far nell'aria quieta la via al suono. In un altro,
anche posteriore, le tre cantatrici sono ferme tutte e tre,
e in un angolo del disegno l'artista ha addirittura scritto
le prime note del motivo...
Il canto torna spesso in quelli anni, nei quadri dì
Michetti: è la voce stessa dell'anima sua. Una bella
contadina che in un paesaggio primaverile canta il suo amore
in faccia alla pianura o al mare, è il più somigliante e
sincero ritratto della sua arte. Per accompagnare le varie
voci di questo canto, quell'impetuoso indugia a scegliere i
gesti e i colori, e li dispone in fila conte un musicista
metterebbe le note più su o più giù, sulle cinque righe
della sua carta. Il primo studio delle sue Cinque ragazze
che cantano è un pastello sommario dove cinque ragazze
facendo catena con le belle braccia s'avanzaro sopra un
declivio che taglia la scena in diagonale; la traccia e in
nero lumeggiata da macchie di verde, d'azzurro e di bianco.
Ma poi il tema è semplificato in un altro abbozzo a bianco e
nero, con tre donne sole, separate, una a testa alta
lanciando il canto al cielo, il soprano, - una a testa più
bassa, il contralto, - una seria più indietro,
l'accompagnamento monocorde e fisso; e le loro braccia son
tese a far nell'aria quieta la via al suono. In un altro,
anche posteriore, le tre cantatrici sono ferme tutte e tre,
e in un angolo del disegno l'artista ha addirittura scritto
le prime note del motivo...
Ma in fondo, alle esposizioni di Milano e di Torino,
Michetti era ancora rimasto quello che era apparso nel
Corpus Domini, e nessun quadro suo aveva superato i
piccoli prodigi di pittura e di osservazione e di poesia che
erano i quadri d'animali dipinti anche prima del 1877. E
ormai egli aveva trent'anni. Ancora era superbo della sua
giovinezza, della sua rudezza paesana, della sua frugalità
spartana, della sua forza muscolare e della sua agilità.
Ancora era capace di rispondere quel che aveva risposto
giovanetto a un cliente il quale, avendo comprato un quadro
di lui perchè l'aveva creduto del Palizzi ed essendo rimasto
meravigliato che fosse invece di quel "pastorello", gli
aveva chiesto: "- E voi che altro sapreste fare? — Cose
centomila volte più difficili, — aveva risposto Michetti. —
Per esempio? — Per esempio, questo," — e gli aveva fatto lì
nel salotto due salti mortali da atterrire un ginnasta. Ma
se si fosse accontentato di quello che ormai sapeva fare e
di quel che tutti ormai sapevano che egli sapeva fare,
sarebbe finito dove è finita, morti Toma, Morelli, Palizzi,
tutta l'altra abilissima pittura napoletana: in un silenzio
che par di tomba.
|
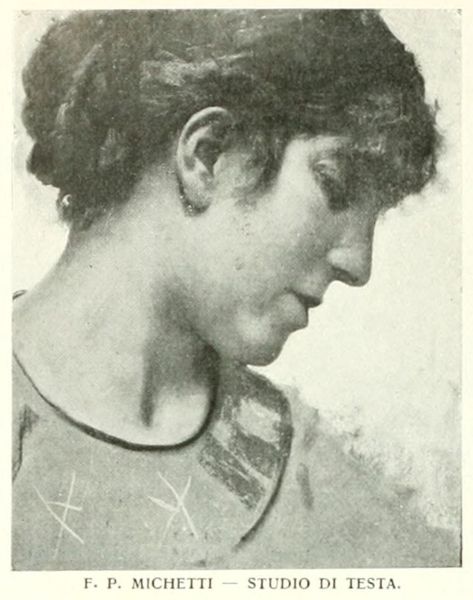 Per fortuna il Michetti era più prudente di quel che
credevano i suoi critici e i suoi laudatori. Continuava, sì,
a dipingere pastorelle e bimbi e contadini innamorati e
contadine belle — di quelle contadine di cui il Millet,
quando le aveva vedute dipinte dal Breton, aveva detto:
Ces filles là sont trop jolies pour rester au village, —
e continuava a dipingerle con una virtuosità che gli faceva
anche dai critici perdonare la leziosaggine, con una
evidenza e un rilievo e spesso con una poesia che le faceva
dai laudatori paragonare a idillii teocritei e ad egloghe
virgiliane. Ma nella solitudine della sua Francavilla dove
aveva ai primi guadagni condotto la famiglia, egli sapeva
ormai meditare anche sul suo avvenire e sul miglior modo
d'uscire con un bel salto e con un po' di fracasso da quel
mar di dolcezze. Gl'intronavano gli orecchi con la sua
grazia, la sua giocondità, la sua tenerezza, la sua
seduzione? Ed eccolo contro ogni aspettativa mandare a Roma
per la grande esposizione del 1883 il Voto: una vasta
tela, un tema lugubre, al chiuso, senza cielo, un pensiero,
come già si diceva, sociale, miseria e superstizione,
stupidità e sangue, una pittura rude che sente il terriccio
del paesetto e che è inquadrata in una cornice stretta come
una bacchetta. E dichiarò che quel quadro l'aveva dipinto in
tre mesi, e in un angolo scrisse «Non finito».
Per fortuna il Michetti era più prudente di quel che
credevano i suoi critici e i suoi laudatori. Continuava, sì,
a dipingere pastorelle e bimbi e contadini innamorati e
contadine belle — di quelle contadine di cui il Millet,
quando le aveva vedute dipinte dal Breton, aveva detto:
Ces filles là sont trop jolies pour rester au village, —
e continuava a dipingerle con una virtuosità che gli faceva
anche dai critici perdonare la leziosaggine, con una
evidenza e un rilievo e spesso con una poesia che le faceva
dai laudatori paragonare a idillii teocritei e ad egloghe
virgiliane. Ma nella solitudine della sua Francavilla dove
aveva ai primi guadagni condotto la famiglia, egli sapeva
ormai meditare anche sul suo avvenire e sul miglior modo
d'uscire con un bel salto e con un po' di fracasso da quel
mar di dolcezze. Gl'intronavano gli orecchi con la sua
grazia, la sua giocondità, la sua tenerezza, la sua
seduzione? Ed eccolo contro ogni aspettativa mandare a Roma
per la grande esposizione del 1883 il Voto: una vasta
tela, un tema lugubre, al chiuso, senza cielo, un pensiero,
come già si diceva, sociale, miseria e superstizione,
stupidità e sangue, una pittura rude che sente il terriccio
del paesetto e che è inquadrata in una cornice stretta come
una bacchetta. E dichiarò che quel quadro l'aveva dipinto in
tre mesi, e in un angolo scrisse «Non finito».
Narravano tutt'i fogli che l'anno avanti, di luglio,
Michetti s'era trovato a un'ora da Francavilla nel villaggio
di Miglianico per godersi la festa e la processione di San
Pantaleone patrono del villaggio. La testa d'argento del
santo "bianca in mezzo a un gran disco solare"»
(1) veniva per quel giorno tratta dal
sotterraneo dove è sempre custodita dietro un cancello di
bronzo, e i canonici del Capitolo avevano pensato di
chiedere a un fotografo di ritrarla. Saputo che Michetti era
là, gli avevano chiesto di soccorrere coi suoi consigli il
fotografo. Michetti aveva acconsentito, e appena il busto
d'argento era apparso sulla porta della chiesa a un cenno di
lui il corteo si era fermato e s'era aperto, la macchina
pronta sul suo trepiede era stata messa in fuoco, il
fotografo e il pittore erano scomparsi sotto lo scialle nero
e la fotografia era stata fatta, fra l'attonito silenzio dei
paesani. Ma poche ore dopo era scoppiato un uragano, la
grandine aveva devastato tutto il raccolto, e i paesani
avevano urlato che quella era la vendetta del santo, il
tangibile seguo del suo abbandono ora che una sua immagine
era stata portata via da Miglianico. Nessuno aveva potuto
frenarli: essi si erano scagliati alla ricerca del pittore
per linciarlo.
|
|
Pagina
1 |
2 |
3 |
4
|
|
|
|